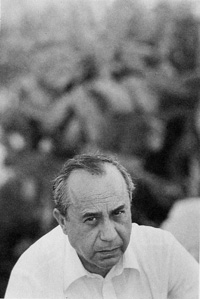|
|
FERDINANDO
SCIANNA
Veridica
Historia della vita di Ferdinando Scianna da lui medesimo raccontata
L'infanzia in Sicilia
Sono nato a Bagheria, in provincia di Palermo, il 4 luglio del 1943.
Si era in piena guerra e due ore dopo, a duecento metri da casa
mia, esplose una bomba. La cosa provocò enorme spavento,
i miei mi avvolsero, per così dire, nella placenta e si rifugiarono
in campagna. Mi piace pensare che di questo racconto ci sia un'eco
in quanto poi Sciascia ha immaginato della nascita del suo personaggio
Candido, anche lui in Sicilia nel '43: una bomba che scoppia e il
protagonista chiamato Candido perché il padre si ritrovò
tutto bianco di calce. Mio padre aveva alle spalle il mito di un
nonno intelligentissimo, pare, e scaricò su di me ambizioni
che forse erano quelle frustrate che suo padre aveva avuto per lui.
Io sono figlio di quel boom del limone, che determinò anche
la psicologia e la cultura di Bagheria. Io la chiamavo Lemon city.
Vi si viveva una specie di febbre dell'oro e, come in un paese del
West, anche da noi c'erano i giocatori professionisti, i killer
professionisti, i personaggi di forte carattere. Forse mancavano
solo gli sceriffi buoni. Era un tempo di violenti contrasti sociali.
Ricordo i braccianti in piazza, all'alba, con paniere, forbici,
zappa e scala, ad aspettare che i proprietari li scegliessero per
il lavoro. La mia, insomma, era una famiglia piccolo borghese legata
all'agricoltura, con un padre che faceva il commesso e aveva grandissimo
terrore della vita, perché si portava dentro, quasi nel sangue,
le catastrofi che avevano colpito la sua famiglia. Ma c'è
l'altro versante della mia famiglia, quello materno. Mia madre è
sempre stata una persona positiva, curiosa, costretta al ruolo di
donna di casa che era il destino di quasi tutte le donne. Mio nonno
era falegname. Mi faceva le spadine, i cavalli di legno. Grazie
a mio nonno andavo moltissimo al cinema. Aveva fatto gli infissi
per il cinema Corso, vicino a casa nostra, e io godevo di ingresso
libero. Ci andavo tutti i giorni, vedevo i film tre o quattro volte.
Credo che è in quelle grandi sale magiche e buie che ho cominciato
a mescolare la vita con le immagini. Il mondo artigiano era tutto
un fare con le mani, costruire pezzo per pezzo il prodotto finito.
Il mondo contadino era fondato su un continuo, terribile rapporto
tra la fatica e il fato. Entrambe le identità me le sento
convivere dentro.
L'adolescenza
Grazie ai limoni, dunque, le cose andarono bene e io studiai al
liceo classico. Poi, cominciarono i conflitti con mio padre. Classici
contrasti generazionali ai quali si aggiungeva il difficile passaggio
epocale che il mondo stava vivendo e di cui non ci rendevamo bene
conto. Il mondo si era messo a cambiare ad una velocità impressionante
dopo secoli di lentezza se non di immobilità. Certezze secolari
si sfaldavano fulmineamente. Mio padre aveva progettato per me cose
nelle quali mi sentivo ingabbiato, come se non avessi dovuto fare
altro che indossare la vita che mi avevano confezionato. Mi sembrava
terribile. Come tutti i ragazzi vivevo desideri di assoluto, e siccome
la mia famiglia era cattolica, io vivevo un rapporto con la religione
intenso e drammatico Poi, verso la fine del liceo, ebbi un'evoluzione
più o meno consapevolmente socialista. Ma il mio essere socialista,
come per tantissimi altri, ha avuto più una radice di cristianesimo
etico sentimentale che di scientificità marxista. Insomma,
cercavo una via di fuga e questa prese il volto bizzarro e inatteso
della fotografia. Quando annunciai che avrei voluto fare il fotografo,
gettai, naturalmente, mio padre nell'angoscia. Riuscii comunque
ad iscrivermi alla Facoltà di Lettere piuttosto che a Medicina
o Ingegneria e vi feci nuove scoperte, rivelazioni, avventure intellettuali.
All'Università, che non ho mai finito, ebbi incontri fondamentali.
Con Cesare Brandi, per esempio. Ricordo benissimo la prima volta
che andai ad una lezione di Cesare Brandi. Questo grande critico
d'arte, che parlava un italiano elegante, nervoso, di forte accento
toscano, nel buio proiettava diapositive su Masaccio. Potrei fare
un excursus sul ruolo delle camere obscurae che hanno segnato la
mia vita: le sale cinematografiche, la camera oscura del fotografo
del mio paese dove ancora bambino vissi l'esperienza magica della
fotografia che appare nel bagno di sviluppo, l'aula buia dove seguii
quella lezione di Brandi. Credo di essere rimasto con la bocca spalancata
per tutto il tempo della lezione. Per la prima volta sentivo parlare
di immagini in quel modo, di rapporto tra la storia e il fare artistico,
tra le immagini e la società, di forma, di strutture significanti
rivelate dalla forma. Finita la lezione andai dal professore e gli
dissi: "Da qui non mi muovo più".
Ho sempre posto irrifiutabili candidature ad essere discepolo di
quelli che riconoscevo come maestri.
|
|
|
Le
prime fotografie
Questa fame di cose sconosciute si accompagnava allora ad una istintiva
passione per il mondo che mi circondava, il mondo contadino. Le
persone che lavoravano in campagna da mio padre erano anche loro
dei maestri. Raccontavano storie straordinarie, mi mostravano una
maniera di vivere difficile, profonda e antica, densa di mitologie.
Era gente che raccontava in maniera sentenziosa e parlava per proverbi.
Cominciai a fotografare feste, oltre che la vita quotidiana del
mio paese e della Sicilia.
Ho cominciato a fotografare intorno ai quindici anni, con una macchinetta
che i miei mi avevano regalato al ritorno da un viaggio. Intorno
ai diciassette anni, quando ero ancora al liceo, la cosa cominciò
a trasformarsi in ossessione. Dopo, in epoca universitaria, la passione
cominciò a strutturarsi in metodo.
In quegli anni cominciai a occuparmi di politica. Per mio padre
la politica era un pericolo, il mio bisnonno ne era stato rovinato,
e che io potessi scontrarmi con i poteri della società, che
a Bagheria significava mafia, faceva parte del suo universo di paure.
All'università seguivo i corsi di Storia delle `tradizioni
Popolari. Occuparsi di politica e di cultura popolare era per me
la stessa cosa. Alla valorizzazione, al recupero politico di tutte
le manifestazioni del mondo popolare affidavamo le speranze dell'avvenire.
Almeno, lo credevamo. Sono poi arrivato alla conclusione che in
realtà riempivamo, come dire, la cassapanca della memoria
della nostra relazione con il mondo contadino, di cui intuivamo
il tramonto. Sapevamo che saremmo andati via dalla Sicilia e costruivamo
vivendolo l'universo del ricordo.
Leonardo
Sciascia
Nel 1963 esposi una parte delle mie foto di feste al Circolo di
Cultura del paese. Il caso volle che Leonardo Sciascia venisse a
pranzo a Bagheria, insieme a un comune amico, Vincenzo D'Alessandro,
assistente universitario di Storia Medievale. L'amico lo portò
a vedere la mia mostra. Io non c'ero. Sciascia lasciò un
biglietto per me con i complimenti. Non l'ho mai più ritrovato
questo biglietto. Non è che sapessi molto di lui, credo avessi
letto solo Il giorno della civetta, Sciascia non era ancora il personaggio
famoso che di lì a poco diventò. Poco dopo pubblicò
Il consiglio d'Egitto. Quando vide le mie foto stava lavorando a
Morte dell'inquisitore. Qualche tempo dopo andai con mio nonno Benedetto
a fotografare la festa del Serpentazzo a Butera, passando poi per
Palma Di Montechiaro, dove Danilo Dolci aveva tenuto una specie
di congresso sulla miseria. La Sicilia di quei tempi mi ricorda
ciò che ora trovo a Benares. Feci delle foto ed ero indignato.
Al ritorno, passai da Racalmuto per cercare Sciascia. Era il 16
agosto, c'erano cinquanta gradi all'ombra e io chiedevo dove abitasse
Sciascia. «Nanà, a la Nuci», mi rispondevano.
Cioè in campagna, nella casa dove ogni estate andava a scrivere
i suoi libri e dove da allora sarei andato a trovarlo anche io,
per ventisette anni, tutti gli anni. Ebbi un vero colpo di fulmine,
avevo trovato la persona chiave della mia vita. Da lì nacquero
moltissime cose. Io ero irruento allora, ancora più di adesso,
come potevo esserlo a vent'anni. Sciascia ne fu divertito, come
spesso era dai mangiatori di vita, lui che invece la vita la metabolizzava
in termini etici e intellettuali e le sue irruenze, che potevano
essere terribili, le riversava tutte nella scrittura. Gli raccontai
di questa mia visita a Palma di Montechiaro e mi chiese di mandargli
le foto. Lui le inviò a Vie Nuove, il settimanale del partito
comunista allora diretto da Davide Lajolo. Pubblicarono un servizio
di otto pagine con didascalie secchissime di Sciascia. Mi ritrovai
con questa pubblicazione impressionante e con un rapporto di amicizia,
profondo e bellissimo, che non è mai più venuto meno.
Le
feste religiose in Sicilia
Verso la fine del '63 domandai a Sciascia se voleva farmi una presentazioncina
per una mostra delle mie foto delle feste religiose alla Biblioteca
Sormani di Milano. Pietro Donzelli, che allora dirigeva Popular
Photography, le aveva mostrate a Giuseppe Torroni e ne era nata
questa mostra. Sciascia scrisse una paginetta, di fatto una specie
di sinossi di quello che poi sarebbe stato il saggio per Feste religiose
in Sicilia. Il libro nacque così. Sciascia doveva presentare
a Bari Morte dell'inquisitore, pubblicato da Laterza, e mi chiese
di accompagnarlo per mostrare all'editore le mie foto e proporgli
un libro sulla Sicilia. Laterza non era interessato ma la sera,
a cena, incontrammo Diego De Donato, editore di testi per lo più
di carattere scientifico e giuridico ma che pubblicava una collanina
bellissima, Piccolo orizzonte, di testi e immagini dove aveva pubblicato
Cesare Brandi, Fosco Maraini e altri. De Donato guardò le
fotografie ed ebbe l'intuizione di farne un libro sulle feste. Chiese
a Leonardo se avrebbe scritto un testo e lui accettò subito,
certo più per me che per lui. Da allora Sciascia non ha più
smesso di farmi meravigliosi regali. Ancora adesso trovo, in librerie
antiquarie, libri di cui ho sentito parlare da lui, magari trent'anni
fa e dove ancora faccio scoperte in una miniera postuma infinita.
Il libro uscì nel gennaio del 1965 e fu un'emozione strepitosa.
Non avevo ancora ventidue anni. Il libro ebbe conseguenze enormi,
non solo nella mia vita, ma anche nella vicenda di Sciascia. Sciascia
diceva nel suo saggio che la religiosità dei siciliani non
ha nulla di metafisico ma è -fatta eccezione per la settimana
santa in cui si contempla il dolore di una madre per la morte del
figlio tradito da un amico-fondamentalmente materialista. Questo
faceva impazzire i cattolici. Il fatto poi che quel discorso fosse
accompagnato da fotografie li faceva arrabbiare ancor di più
perché consideravano che questo portasse una sorta di prova
documentale al discorso. Fortunato Pasqualino scrisse una stroncatura
di due colonne sull'Osservatore. Dovevo fronteggiare, per esempio,
l'argomento dell'artista: "Siamo contenti di avere qui il giovane
Scianna che è un artista, lo si vede dalle sue fotografie.
E che cos'è l'arte? Un sogno, che può diventare mistificazione.
Come in questo caso. I siciliani, infatti, sono religiosissimi,
eccetera, eccetera". Facendo questa esperienza mi resi conto
che la promozione del fotografo ad artista era pericolosa, e la
convinzione mi è rimasta, visto che si usa la definizione
di artista come una specie di insulto, una sorta di strumento per
togliere senso storico al mio lavoro.
Molti dissero che le mie foto erano nate dopo l'incontro con Sciascia
e che io ne ero stato subornato. In realtà, il nostro incontro
avvenne dopo che io avevo fatto una buona parte di quelle fotografie,
ma ho sempre pensato che in effetti l'incontro con Sciascia abbia
avuto su di me un paradossale effetto retroattivo. Nel senso dell'arricchimento,
si capisce, non certo del plagio. Avevo trovato il significato del
mio lavoro a partire dalla prospettiva che Sciascia gli aveva dato.
La
partenza dalla Sicilia
Ma quel libro ebbe anche un suo destino specificamente fotografico.
Non so chi, qualcuno lo 1 fece avere a Popular Photography americano
che nel 1966 dedicò otto pagine del suo annuario a questo
libretto pubblicato da un piccolo editore italiano, da un giovane
fotografo sconosciuto dicendo che era: «The most impressive
photobook published this year». Molti intorno a me dissero
che dovevo andare a New York. Figurarsi, non ero neanche stato a
Roma. Il mondo mi terrorizzava. Però l'attenzione ricevuta
mi incoraggiò, mi diede l'illusione che avrei potuto fare
quel mestiere. Ma avevo paura, temporeggiavo. In una delle presentazioni
delle Feste Religiose in Sicilia, avevo conosciuto un ragazzo della
mia età, il futuro regista, poi Leone d'oro a Venezia, Gianni
Amelio. Pochi mesi dopo il nostro incontro, Amelio si trovò
ad essere assistente alla regia di Vittorio De Seta per il film
Un uomo a metà. Avevano bisogno di un fotografo di scena
e Gianni pensò a me. Questo è stato il mio primo lavoro
professionale.
Nel 1966 me ne andai a Milano. Centinaia di migliaia di siciliani
sono partiti, e in ben più drammatiche condizioni. Ma hanno
detto che il mio fu un atto di coraggio. Io credo che i miei atti
di coraggio siano sempre stati fughe da una nave in fiamme. Non
c'era possibilità di ritorno, se fossi tornato sarebbe stata
una sconfitta esistenziale totale. Per la verità, tutto è
stato poi relativamente facile. Nel settembre del 1967 fui assunto
all'Europeo, grazie a Roberto Leydi, che conosceva le mie fotografie
e cominciai a fare dei reportage, sempre con molto entusiasmo e
poca pratica. Devo moltissimo alla pazienza e alla disponibilità
delle persone dell'Europeo che mi hanno permesso di imparare il
mestiere facendolo.
L'Europeo
Nel '68 è nata mia figlia Francesca. Ciò significa
che nel '67, a ventiquattro anni, facevo il fotografo in un grande
settimanale senza essere ancora professionalmente preparato e a
25 anni, ancora meno preparato, ma con lo stesso entusiasmo, mi
ritrovai a fare il padre. All'Europeo ho cominciato a imparare il
mestiere di fotoreporter in un contesto irripetibile nel giornalismo
italiano. C'erano personaggi come Franco Pierini, Gianfranco Venè,
Guido Gerosa, Roberto Leydi, Alberto Ongaro, Oriana Fallaci, Enzo
Magri, Lina Coletti, Marco Nozza, Lietta Tornabuoni, Aldo Santini,
Gianfranco Moroldo, e ne dimentico. Una specie di università
del giornalismo italiano. Tutti erano grandi intellettuali, a cominciare
dal direttore Tommaso Giglio, poeta, traduttore di Eliot, collaboratore
di Elio Vittorini. Era un mondo di gente fuori dall'ordinario e
una grande scuola. Prendi anche dei vizi, si capisce, che sono poi
i vizi del giornalismo: la velocità, per esempio, la tendenza
ad annoiarsi rapidamente di una situazione perché si ha subito
voglia di qualcos'altro. Una maniera di vivere e lavorare, peraltro,
che mi assomiglia. Io ho, lo dico con rammarico, una tenacia discontinua
o, per meglio dire, una discontinuità tenace. Preferisco
moltiplicare le esperienze piuttosto che concentrarmi su un solo
grande progetto. E ho sempre paura di rimanere in superficie. Per
me il giornalista è uno specialista di niente che va dappertutto
e appena cominci a capirci qualcosa se ne va da un'altra parte.
All'Europeo la mia formazione cresceva soprattutto grazie al rapporto
con i colleghi giornalisti con cui viaggiavo. Quando si andava a
fare una storia si viveva insieme e vedevo, sentivo, capivo, come
la notizia veniva cercata, elaborata, scritta, trasformata in articolo.
L'insieme di queste esperienze mi ha portato a scrivere anch'io.
Mi dicevano, sei troppo intelligente, dovresti scrivere, come se
le foto le possa fare anche un cretino. Scrivere, per me, nella
quotidianità del lavoro, ha significato soprattutto la scoperta
difficile della solitudine. Il fotoreporter è solo. Guarda,
è costretto a pensare. E vedendo e riflettendo cambia e cresce.
Ho cominciato a scrivere nel 1973. Il mio primo articolo l'ho fatto
sull'invasione della Cecoslovacchia, nel '68, ma prima che Giglio,
il direttore, che se ne era entusiasmato, riuscisse a fare accettare
alla corporazione da una parte e alla azienda dall'altra che un
fotografo potesse diventare giornalista ci sono voluti anni. Poi,
colpo di scena, nel 1974 Giglio mi mandò a Parigi.
Parigi
Giglio mi chiese di andare per le elezioni presidenziali, quelle
in cui fu eletto Giscard d'Estaing, e di cercarmi una casa perché
sarei rimasto come corrispondente. La cosa mi gettò nell'entusiasmo
e nel terrore.
Ci sono rimasto dieci anni. Ho fatto a Parigi il giornalista politico,
culturale, leggero, perfino economico e mi sono ritrovato a intervistare
il presidente della Banca di Francia e Michel Foucault, Sartre e
le cantanti di moda. Sono riuscito ad avere un ottimo inserimento
anche nella realtà professionale e culturale francese, assolutamente
inimmaginabile al mio arrivo. Ho conosciuto personaggi straordinari
come Claude Julien, direttore di Le Monde diplomatique, che avendo
saputo di una mia certa analisi della situazione italiana, mi telefonò
per chiedermi un articolo e mi ritrovai a essere il commentatore
di politica italiana per il suo prestigioso giornale. Ho conosciuto
Maurice Nadeau, grande personaggio della cultura francese, che pubblicava
La Quinzaine litteraire; anche lui mi chiese di collaborare e per
anni, su quelle pagine, tenni una rubrica di libri, mostre, immagini,
fotografie. Mi ritrovavo più a scrivere che a fotografare,
ma ho sempre saputo di essere un fotografo che scrive.
Cartier-Bresson
Poi, grazie al libro Les Siciliens, pubblicato in Francia da Denoél
e in Italia da Einaudi nel 1977, ho conosciuto Cartier-Bresson e
ne è nata una grande amicizia, sempre per quella mia capacità
di diventare un'ostrica appena incontro una roccia che valga la
pena di essere abitata. Il rapporto con Cartier-Bresson è
stato un altro dei miei grandi incontri con anziani maestri. Come
per Sciascia, che quando l'ho conosciuto anziano non era, ma io
ero un ragazzo, per Carlo Doglio, straordinario intellettuale anarchico
che viveva a Partinico, per Lamberto Vitali. Per me Cartier-Bresson
era un monumento e mi sembrava assurdo andargli a rompere le scatole.
Però, quando Les Siciliens uscì gliene inviai una
copia con dedica devotissima. Poco tempo dopo, mi scrisse un biglietto
nel quale diceva che il mio libro gli aveva fatto di nuovo venire
voglia di fotografare e un giorno avrebbe avuto piacere di incontrarmi.
Qualche mese dopo, Romeo Martinez, conosciuto per caso e con cui
eravamo diventati amici - un altro grande vecchio che mi ha insegnato
una quantità di cose importanti - mi invitò a casa
sua per incontrarvi il signor Cartier-Bresson. Siamo diventati molto
amici. Lui è stato ed è con me di una eccezionale
generosità critica e umana. Un altro rapporto determinante
nella mia vita. Infatti, quando in seguito a tutta una serie di
complesse traversie personali e professionali decisi di dimettermi
dall'Europeo e tornare a Milano, Henri mi spinse a presentare la
mia candidatura a Magnum.
Magnum
La sua proposta mi fece compiere un gesto che altrimenti non avrei
mai osato, non considerandomi affatto all'altezza. Fui accettato.
Così che, al momento di tornare in Italia, nel 1982, entrai
a Magnum.
Non sapevo cosa significasse essere membro di Magnum, né,
per la verità, l'ho capito adesso dopo 17 anni. In più,
sbagliando lasciavo Parigi, nel momento in cui sono entrato Magnum.
Ripresi, a Milano, a lavorare con i giornali con fotografie e testi.
Forse speravo che Magnum sarebbe stato una specie di paracadute.
Mi ritrovavo in una situazione di precarietà economica dopo
anni di buon stipendio e con due figlie da mantenere. Ma Magnum
non è un paracadute. Il fatto è che molte cose avvengono
dove sono gli uffici e io, in questo senso, vivo il problema della
distanza. Magnum continua a sopravvivere secondo l'utopia egualitaria
dei suoi fondatori, in modo misterioso riesce a fare convivere le
più violente contraddizioni. Questa è la cosa che
più mi appassiona. Per quanto mi riguarda, sicilianissimamente,
ho difficoltà a sentirmi parte di qualunque tipo di gruppo,
ma so che se devo riferirmi ad una appartenenza è in quella
tradizione che mi riconosco.
Certo, si è creata una mitologia intorno a questo gruppo,
come se la grande fotografia di reportage fosse passata soltanto
per Magnum. Naturalmente, non è affatto così. Magnum
è stata, ed è, un confronto, una misura, un rapporto
anche di tipo antagonistico. Senza i contrasti tra il proprio orgoglio
e l'attitudine ecclesiale, da setta, che qualche volta Magnum ha,
certi grandi risultati individuali non sarebbero stati probabilmente
raggiunti.
La
moda
Entrato a Magnum e tornato in Italia, mi ritrovavo per la prima
volta a fare quello che sempre avevo voluto fare: il fotografo indipendente.
E accadde persino che mi chiedessero di realizzare un catalogo di
moda. Ancora più inaspettato che questo coincidesse con un
viaggio in Bolivia durante il quale mi ero innamorato di quel paese.
Vi incontrai il direttore di una agenzia di cooperazione internazionale
impegnata sul posto, nacque l'idea di un lavoro su un villaggio
di minatori. Così, i due lavori, la moda e Kami, in Bolivia,
nacquero praticamente nello stesso periodo.
Dolce e Gabbana mi cercarono nel febbraio del 1987, se non sbaglio,
e nel mese di aprile realizzammo il primo catalogo. Non avevo mai
fatto fotografie per la moda e di colpo mi ritrovai con Marpessa,
modella bellissima, famosa, ma io non lo sapevo, con ampia libertà
di inventare con lei immagini di moda, in Sicilia. Avevamo pochi
soldi, la macchina per andare in giro l'aveva prestata il fratello
di Domenico Dolce, non avevamo parrucchiere né truccatore,
e io, istintivamente, collocavo Marpessa nello stesso contesto della
mia vita, negli stessi posti della mia infanzia: Bagheria, Palermo,
Porticello, Sant'Elia, luoghi dove avevo vissuto, che
avevo fotografato da ragazzo. Mescolavo la pratica del reporter
a quella, a me ignota, del fotografo di moda. In quel lavoro hanno
coinciso una quantità di cose che sposavano l'artificio codificato
della fotografia di moda con qualcosa che attraversava autenticamente
elementi sia autobiografici, sia stilistici. Il risultato, pur essendo
ovviamente il prodotto dell'artificio, aveva probabilmente dentro
un soffio di autenticità, qualcosa che fece dire a Sciascia
che ero riuscito pirandellianamente a fare diventare creatura il
personaggio.
Per me ha significato un immediato, paradossale successo come fotografo
di moda: credo di avere lavorato per quasi tutti i grandi giornali
del mondo, compresi Vogue America, Vogue Francia, Marie Claire francese,
spagnolo, Vogue Spagna, Amica, Moda, Grazia, Stern,... Qualcuno
mi diceva che avrei dovuto scegliere una testata prestigiosa e cercare
di lavorare solo per questa. Ma io mi divertivo talmente. Una specie
di gioco. Per sette otto anni, di cui cinque in maniera quasi esclusiva,
sino al punto di farmene venire la nausea, mi sono molto divertito.
Dalla mia esperienza con le foto di moda è nato il libro
Marpessa: un libro su di lei e sul rapporto tra il fotografo e la
modella, un racconto, credo, piuttosto singolare nel panorama dell'editoria
fotografica. Racconto su una modella, su una persona, documentario,
racconto autobiografico, persino. Ho ricostruito tutta una panoplia
di gesti che si ripetono, lo specchio,
4 la sottoveste, certi sguardi, certe atmosfere, che facevano parte
del mio immaginario erotico di bambino del sud in un mondo di apartheid
tra uomini e donne. Altro che psicanalisi.
Pubblicità
La moda ha messo in discussione molte cose, ha rimescolato le carte,
le mie idee, la mia pratica della fotografia e ha fatto nascere
nuove occasioni professionali. La moda è un mondo che si
postula come presente permanente, il passato, se esiste, esiste
come revival, non come memoria. Succedeva, ad esempio, che dessero
come novità assoluta quella mia maniera di fare fotografie
ed ero io a dirgli che il primo Avedon, William Klein avevano fatto
cose simili sin dal '56-'57. Hanno addirittura utilizzato una definizione,
« moda-reportage che era stata utilizzata per Frank Horvat,
per me davvero un maestro, che certe cose le ha fatte quaranta anni
fa. Se parli di Munkacsi, quasi nessuno sa chi fosse. Nel mondo
del fotogiornalismo, che invece qualcosa di me sapeva, questa storia
della moda aveva impressionato e sorpreso, come la scoperta di una
corda insospettata al mio arco. Non solo mi sono ritrovato da un
giorno all'altro a fare il fotografo di moda, ho avuto anche opportunità
nel campo della pubblicità che da reporter non avevo mai
neanche sfiorato.
Non so quanto sia stato e sia un buon fotografo pubblicitario, però
ne ho fatta abbastanza, buona e cattiva, spesso interessante, dalla
quale ho imparato molte cose e che in ogni caso è meglio
pagata di qualunque altro tipo di fotografia abbia fatto e faccia.
Questo tipo di lavori mi hanno aiutato a scoprire che il fare fotografie
non è poi così radicalmente diverso dal trovarle.
Adesso, con immutata passione, divertimento e ironia opero nei campi
più diversi. Faccio un po' di moda, un po' di pubblicità,
il reportage e cerco più che mai di fare ritratti. Inoltre,
come in questo momento, recupero materiali dal mio archivio per
numerosi progetti. Nelle mostre non faccio distinzioni tra le immagini
nate dal mio lavoro di fotoreporter e quelle di moda, per esempio.
Le inserisco tutte in una continuità, che è poi quella
della mia pratica professionale.
|