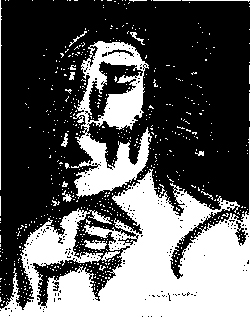|


|
LA SCELTA DI MIGNECO
di Raffaele De Grada
In un quaderno monografico, pubblicato da Bestetti nel 1955, su Migneco, il grande poeta siciliano Salvatore Quasimodo scriveva che «la Sicilia di Migneco non è contemporanea, in quanto il pittore svolge altrove i suoi moti drammatici... ama, cioè, natura e contadini della sua terra in una configurazione eterna». Era il sincero riconoscimento di un siciliano ad un siciliano: entrambi hanno amato la Sicilia del sole, dei giardini e degli alveari e non soltanto quella dei latifondi e dell'occupazione delle terre, nobilissimo tema degli anni del realismo, quelli appunto in cui usciva il quaderno monografico sopraddetto.
Tale «configurazione eterna» che Quasimodo notava allora, distingueva l'opera di Migneco nell'ambito del movimento realista, allora vivace, del quale Migneco era giustamente considerato uno dei protagonisti. Niente di occasionale, di cronaca, nell'arte di Migneco ma neppure l'astoricità di cui l'eredità novecentesca poteva averlo caricato. Per Migneco l'«eternità» che fa sempre giovani e attuali le sue famiglie di pescatori e di contadini è nata nel suo villaggio, vicino a Messina, insieme a lui. Vale a dire che Migneco non è giunto alla pittura per passione figurativa da riempire con i contenuti che intanto la sua esperienza di uomo gli suggeriva. I contenuti del realismo erano nati con lui pittore, naturalmente. Con la pittura egli esprimeva il suo mondo, che era nato con lui. Un fatto di cui ci eravamo accorti fin dai tempi di «Corrente», prima della guerra, e che è continuato nel tempo, tanto che Migneco alla figurazione realista è giunto per forza, non poteva essere altrimenti: non per un fatto ideologico, ma di vita.
Migneco è giunto dunque all'opera, fin da quando venne a Milano intimo amico di Beniamino Joppolo, messinese, non per un impulso di ideologia ma per un ritmo di vita. La pittura ha una cadenza di vita, come accadono i fatti normali in una famiglia, dalla nascita alla morte. Ma, proprio perché egli è pittore della norma (madre e figli, donne e pescatori, animali, mercati, lampare), Migneco esce dalla norma medesima con il forte contrasto dei suoi colori, che danno un'immagine visionaria. Essa si trasferisce nell'iperbole per cui cose e persone compiono gesti in un mondo vero ma anche traslato nella fantasia.
Così ho conosciuto Migneco negli anni duri, prima della guerra, fino a quelli in cui fu contestato, ma ebbe molto successo, negli anni del realismo; e ancora — e gli dobbiamo riconoscere una rara coerenza — in quelli più recenti quando Migneco è diventato un grosso nome internazionale e di mercato, un mercato facile perché, a differenza di tanti altri, Migneco ha venduto allegria, quadri di piacevole impatto con la vita. Giunti a questo punto, alla giusta consacrazione che gli viene dalla sua città natale, Messina, da questa Sicilia che per lui è sempre stata la dolce-amara primavera che l'ha accompagnato per tutta la vita, mi sento in dovere di testimoniare dei tre momenti in cui Migneco è entrato da par suo nella storia dell'arte italiana del nostro secolo.
Primo momento, gli anni di «Corrente» e precisamente dal 1935 al 1945. Già nei «lividi modi serpeggianti dell'epoca di "Corrente"» (definizione di De Micheli in una monografia stampata da Macchi di Pisa nel 1966) si intuiva non la descrizione dell'angoscia degli anni precedenti la guerra, ma una grande aspirazione alla felicità del vivere, una felicità che sembrava impossibile da venire. Migneco si differenziava dalla pittura del tempo perché non amava dipingere «nature morte» e «paesaggi», come usava allora. Sotto l'impalcatura del fascismo resistevano soltanto i fragili mondi familiari di vita e di arte. Essi hanno lasciato fino a noi quella scia di luce che ha segnato il loro percorso.
Migneco no. Fu subito notato il suo «espressionismo», che fu uno dei principali patrimoni di «Corrente». Voleva dire non evadere dalla pittura, alla quale lo conduceva naturalmente la sua indole di pittore, ma farla rinascere secondo i grandi impulsi che venivano da Van Gogh e dall'arte moderna europea. E in ogni quadro di Migneco la pittura rinasceva ogni volta.
Con tutto l'onore che deve essere reso a coloro che hanno avuto il buon senso di rimanere sulla sponda e non imbarcarsi sulla nave dell'ufficialità fascista, merito molto maggiore va attribuito a questi artisti di «Corrente» che, nei termini dell'allegoria, hanno detto della condizione dell'uomo di fronte alla tirannia e alla guerra. Soltanto raramente e spedalmente negli anni di guerra gli artisti di «Cor-rente» affrontavano direttamente, alla maniera realistica, i temi dell'oppressione e della violenza. Rifiutando la comoda scappatoia dell'astrazione, che malamente è stata definita una forma d'opposizione, essi trasferivano in un'allegoria dal reale la luce schietta dell'insofferenza a un modo, a un costume di vita. Nella poetica di «Corrente» Migneco portò l'immagine dello stato brado dei ragazzi contadini a caccia di lucertole sotto l'ombra rara dei boschi della sua Sicilia, lungo i torrenti arsi.
Come cultura, Migneco inclinava allora verso un Van Gogh notturno. A riguardare i suoi quadri d'allora, sembra che siano incorniciati dalla luna, non hanno quell'atmosfera solare che distingue poi il suo periodo realista. La pittura di Migneco ci presentava una svolta nell'arte del tempo tutta intenta alla ricerca della bella materia e dei valori esistenziali (da Morandi a De Pisis). Il suo antinovecen-tismo aveva però qualcosa di comune con l'idea sironiana (nessun rapporto formale) di arte decorativa («muri ai pittori»). Certamente, se Migneco si fosse presentato prima, Sironi l'avrebbe chiamato ad affrescare una parete alla Quinta Triennale. Tant'è vero che la critica notò poi come Migneco si avvicinasse ai muralisti messicani, in particolare ad Orozco. Migneco, antifascista, tanto che aveva anche sofferto un arresto, mutava la presenza del pittore nello spazio postimpressionista come conseguenza della diversa posizione d'intervento dell'arte nelle circostanze dell'uomo, nel coinvolgimento dell'artista nei problemi del mondo, che erano quelli della libertà e della pace.
Secondo tempo, quello del «realismo». Il candore drammatico che gli fece dapprima amare Van Gogh (una fede nuziale, come fu per Birolli l'amore per Ensor) a contatto con il sorgere delle organizzazioni democratiche della nuova Italia, porta il pittore siciliano a una forte, elementare figurazione realistica. Il suo mondo siciliano di contadini, di pescatori, di madri, lo riduce alla sorgente pura della sua ispirazione, come se il pittore incominciasse a risalire il fiume della vita verso l'infanzia. La sua tavolozza cambia, dall'uso delle terre a una pittura ad aghi di colore, vibranti di verdi, di azzurri, rossi e gialli. L'impegno del pittore non è tanto ora quello della proiezione del proprio stato d'animo e pensiero sulle cose, quanto quello di far parlare i suoi personaggi e la loro fatica. Con grande tenacia per tutti gli anni cinquanta e oltre Migneco ci ha raccontato di questo mondo e il suo impegno ci sembrava contenesse anche una volontà di documentarlo, come se quel mondo dovesse sparire per sempre.
Ciò che ho amato soprattutto nella pittura di Migneco in quegli anni è l'aver egli piegato il suo forte colorire espressionista, il carattere difficile della sua ragnatela di contorni ad una qualità squisita di pittura di memoria, di documento. Nella Sicilia di Migneco dell'epoca ritrovo quel sentimento struggente di mondo che si perde che ho tanto goduto nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. La Sicilia di Migneco non si presentava infatti con il pittoresco e anche l'aspro del presente, ma con l'incanto di una terra lontana, quella che si è lasciata ma anche quella alla quale si può far ritorno in una nuova emigrazione all'incontrario. Difatti sotto l'energia dei contrasti cromatici di Migneco, sbocciavano come fiori selvaggi le immagini di cui le cronache ci parlavano ogni giorno, ma che la trasformazione meccanica della società, anche in Sicilia (i pozzi di petrolio, l'industrializzazione selvaggia), ci avvertiva che era un patrimonio che si andava perdendo, come se quei fiori stessero per essere spazzati da un'orribile macchina ripianatrice in vista di una costruzione.
Guardando oggi i risultati di Migneco di quegli anni, tra i più sicuri e sinceri del movimento realista, si capisce il perché di quella sua personalità sempre assorta, che sembrava vivere un po' qui da noi e un po' là, nella sua terra accanto alla sua gente folla, perché l'isolato Migneco ama in realtà il collettivo e nessuno in particolare; niente in lui ha i crismi dell'individualismo.
Il terzo tempo nell'opera di Migneco è quello che egli sta ancora vivacemente vivendo. Per tutto l'arco degli anni sessanta e settanta Migneco ha dimostrato che si poteva essere pittori moderni e attuali anche senza piegare ai modi pressoché universali prima dell' «informale », poi dell' «iperreale», con tutte le forme secondarie che si conoscono. Questa coerenza sarebbe già un fatto importante se tuttavia al suo interno non si manifestasse anche un fatto nuovo: nell'opera più recente di Migneco si avverte una più acuta sensibilità di tutto ciò che mette oggi in pericolo non solo la felicità ma la vita stessa dell'uomo. Le sue figure hanno perso la fiera serenità dell'epoca realista, paiono dilacerate, macerate dai diabolici ingranaggi della vita odierna dove il potere in tutti i suoi aspetti determina la vita dell'uomo. Senza inventarsi soggetti nuovi, continuando anzi a variare e approfondire i medesimi, Migneco è cambiato dentro. La sua sensibilità, che gli conosciamo dai tempi di «Corrente», gli fa avvertire l'assurdo di una vita che appariva tutta in progresso e che si rivela ancor più esposta al gioco dell'arbitrio, e non soltanto in Sicilia, di quanto non fosse prima. I suoi critici, ormai numerosissimi, hanno avvertito questo dramma nuovo che sembra percorrere l'ormai ben nota strada maestra dell'arte di Migneco. Questa mostra pertanto, nella sua patria, non può essere soltanto celebrativa, perché ancora una volta Migneco è l'ago sensibile di una situazione precaria che noi speriamo, proprio qui in Sicilia, non volga al peggio. Ancora una volta l'arte di Migneco è l'antiretorica: come ai tempi di «Corrente», in quelli del realismo, oggi.
|
|
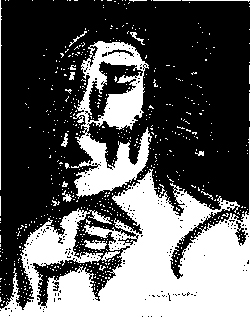




|
TESTIMONIANZA PER MIGNECO
di Mario De Micheli
Milano era piccola a quel tempo, piccola almeno per noi, intellettuali, poeti, scrittori, pittori, che vi eravamo giunti da ogni parte, ma soprattutto dal Veneto, dal Piemonte, dalla Toscana, dalla Liguria e dalla Sicilia: piccola perché era facile ritrovarci insieme in un caffè, in un'osteria; e piccola perché eravamo anche in pochi ad avere le stesse idee, gli stessi sentimenti, le stesse inquietudini e insofferenze. C'era chi parlava con eloquenza e macinava pensieri ribelli e chi era intimamente ribelle ma se ne stava taciturno in disparte ad ascoltare. È in questo atteggiamento che allora ho conosciuto Migneco: del resto la sua silenziosità, sin d'allora, cominciava a diventare leggendaria. Ragionatore infaticabile e facondo era invece Beniamino Joppolo. Anch'egli, come Migneco, era salito al nord da Messina. Aveva anche la stessa età poiché, come Migneco, era nato nel 1908. C'era anche un altro siciliano che, nello stesso periodo, fra il '33 e il '34, era arrivato a Milano: Salvatore Quasimodo. È naturale quindi che i tre diventassero amici. Quasimodo non era muto come Migneco ma neppure era verbalmente abbondante come Joppolo: era di parola tagliente, pungente, epigrammatica, sempre pronto a colpire i retori più celebrati del momento. Dei tre, Joppolo era quello maggiormente politicizzato. Qualcuno, benevolmente scherzando, alludendo a questa sua qualità, talvolta gli sussurrava all'orecchio: «Avanti Joppolo, alla riscossa...».
Ma non è che la coscienza di un'opposizione non fosse ugualmente viva sia in Quasimodo che in Migneco, anche se in quel primo periodo poteva essere un'opposizione più vaga e generica. Erano gli anni del movimento di «Corrente», del giornaletto fondato da Treccani appena diciottenne, che in breve acquistò sicuro rilievo con la collaborazione alle sue pagine di tanti nomi decisivi per la cultura italiana, da Montale a Saba, da Banfi a Paci, nonché per la conoscenza che favorì di poeti come Eliot, Lorca, Eluard, Yeats e di altri, per la prima volta tradotti in Italia; o di romanzieri corna Kafka e Joyce; o di filosofi come Heidegger e Sartre; o di musicisti come Hindemith. Voglio dire che l'opposizione, in vario modo, più definita o meno, era nel cuore di tutto il gruppo che su «Corrente» scrisse o a «Corrente» partecipò: parlo di Gadda, Pratolini, Bilenchi, Gatto, Vittorini, Ferrata, Penna e, tra gli artisti, Mafai, Guttuso, Birolli, Manzù, Sassu, Broggini, Grosso, Fontana, Valenti, Badodi, Cherchi, Paganin; tra i critici, Bini, Labò, De Grada.
Ma la vicenda di «Corrente» è già stata, da più parti, ampiamente raccontata, né qui è il caso di ripeterla, anche se è utile ricordarla poiché, in questo clima spirituale, Migneco s'è formato e ha vissuto. Tra l'altro, in via della Spiga, tra il negozietto di un fruttivendolo e quello di un calzolaio, c'era anche la «Bottega di Corrente», una minuscola galleria dove Migneco tenne la sua «personale» milanese del '41. La prima, invece, l'aveva tenuta a Genova, alla Galleria Cairola, presentato da Joppolo. Ricordo l'inizio di quella presentazione: «La pennellatura lunga, aggressiva, di preferenza verde, tra cui fili di giallo cromo vibrano, è quella che popola maggiormente il mondo pittorico di Migneco...».
È la prima definizione della sua caratteristica pittura di quella lontana stagione. I verdi e i gialli erano veramente i suoi colori fondamentali: verdi e gialli macerati insieme con serpeggianti e livide striature, dove le suggestioni di Van Gogh si scioglievano dentro irritati e tristissimi umori. Di Van Gogh, Migneco aveva visto soltanto le riproduzioni, non gli originali. Ma questo, di non aver visto gli artisti di cui erano innamorati, non era unicamente il caso di Migneco. A Parigi c'erano andati o potevano andarci davvero in pochi. Si parlava così di Delacroix e Renoir o di Ensor, Munch, Dix, Nolde, Despiau, Picasso senza averli visti direttamente. Eppure le suggestioni erano vive anche se ricevute a quel modo e quindi trasformate o addirittura stravolte attraverso il filtro di fervori diversi. Così Migneco guardava e leggeva Van Gogh col sentimento della sua solitudine e con la co-scienza della sua infanzia e della sua adolescenza perdute, remote, percepite ormai come mito dolorosamente irrecuperabile. La linea lingueggiante, che a Van Gogh serviva per esprimere la coincidenza del suo slancio ansioso con le energie che pervadono l'universo, serviva a Migneco per rivelare l'angosciante e instabile condizione della sua esistenza, l'ossessionato inseguirsi dei propri pensieri, il manifestarsi di impulsi destinati a ritornare immancabilmente su se stessi. Ma ciò che, all'origine, era senza dubbio soltanto un motivo personale, nel risultato delle sue immagini diventava invece uno dei segni emblematici di quella generazione, la seconda generazione del '900, che in «Corrente» si era appunto riconosciuta. In questo senso, un'opera come L'uomo dal dito fasciato, dipinto nel '40, appare tra le più significative. Si tratta vagamente di un autoritratto, dove Migneco si è rappresentato col volto fisso, con lo sguardo assorto in se stesso, come immerso in un proprio sogno interiore. L'avvolge una sorta di mantello, ancora una volta cromaticamente acido, a filamenti giallo-verdi, aperto tuttavia sul davanti per lasciare scoperto un maglione rosso che sale sino alla gola della figura. Questo rosso è un fatto nuovo, sottolineato dalla mano destra che vi posa contro, col dito medio ferito e fasciato di nero, un nero che si ripete stretto intorno al polso. Ma non è solo questo particolare che colpisce nel quadro: ci sono anche i fiori, quattro garofani alti sul loro gambo, che sembrano nascere dal petto stesso dell'artista.
È una simbologia da interpretare, del resto abbastanza facile di lettura. Più di un pittore di «Corrente» ricorreva allora ai simboli e alle allegorie per comunicare idee e giudizi apertamente non manifestabili. Gli «uomini rossi» di Sassu, le «crocifissioni» di Manzù e Guttuso, i «poeti» di Birolli, erano, per chi sapeva guardare, allusioni sufficientemente chiare. Ma anche i coltelli piantati sui tavoli delle nature morte accanto a un drappo rosso, anche un bucranio che rimandava a Picasso. Il quadro di Migneco va dunque guardato nello stesso modo. Da questo punto di vista l'interpretazione è lampante. Forse, quale precedente di quest'opera, si potrebbe ricordare L'uomo col guanto nero di Levi, eseguito nel '31, oggi conosciuto col suo giusto titolo: L'eroe cinese. Anche in quel caso i presupposti ideali erano analoghi. Ma L'uomo dal dito fasciato, per quanto riguarda Migneco, può anche dirci qualcosa di più preciso e cioè che Migneco, accanto alle dispera-zioni, all'inseparabile nostalgia per la sua mitica adolescenza e alla propria intima solitudine, celava pure un sogno di speranza possibile, il che sin d'ora può avviarci a capire anche le sue scelte postbelliche.
Nel '42, al IV Premio Bergamo, si poté vedere lo schieramento di «Corrente» quasi al completo. Alcune opere destarono scalpore: la Crocifissione di Guttuso e la Pietà di Cassinari: le due Vergini nude parvero irriverenti. Ma, ugualmente, le opere di Birolli, di Vedova, di Morlotti, di Treccani e di Migneco indicavano una direzione di ricerca sviluppatasi ormai totalmente autonoma e divergente da quelle che per anni erano state le proposte novecentiste o metafisiche. Migneco esponeva il capolavoro dell'intero periodo: i Cacciatori di lucertole, dunque ancora un quadro dedicato al ricordo dei suoi liberi anni siciliani, ma più sicuro di piglio, più ricco di movimento. La Sicilia insomma, sia pure irraggiungibile, continuava ad essere per lui un punto insostituibile di riferimento, nonché il «repertorio» poetico più persuasivo delle sue immagini. Come per Quasimodo. Un giorno, a quest'epoca, non ricordo più dove, forse in un caffè intorno a via della Spiga, e non ricordo neppure con chi, forse con Joppolo, ho incontrato Migneco. Ma se la memoria sulle circostanze di quell'incontro è vaga, è invece preciso il ricordo di Migneco, anche perché mi trovai davanti un Migneco stranamente diverso da quello che conoscevo. Come sempre non parlava, ma in cambio, le mani vicino alla bocca, con un curioso strumentino produceva strani suoni, vibrazioni dolci e metalliche a un tempo. «Che fai?» gli chiesi sorpreso. Mi rispose: «Suono il marranzano! ». E aveva negli occhi una luce che non gli avevo mai vista.
Poi la guerra ci disperse, la Resistenza ci coinvolse. Badodi cadde sul fronte russo, Bini morì nel corso di un bombardamento a Bologna, Sereni fu fatto prigioniero in Africa, Grosso venne confinato, Labò fucilato a Roma... Migneco lo rividi solo nel '46. Anche per lui quegli anni erano stati duri, senza poter dipingere, alla macchia. I primi quadri suoi, che mi trovai davanti, segnavano senz'altro un distacco dall'esperienza precedente. Erano disegnati con un segno più deciso e il
18 colore aveva un timbro più netto. Ma questa non era l'unica differenza dalle tele anteguerra. Anche i soggetti e il modo di trattarli mostravano una nuova inclinazione sia di natura plastica che espressiva. S'avvertiva insomma che in Migneco aveva avuto inizio un processo di mutamento. Ma in realtà ci sentivamo tutti mutati o in via di mutamento. Quanto era accaduto ci aveva maturati. La gioventù era finita nel tumulto dei giorni difficili e drammatici che avevamo vissuto, nei rischi corsi, nel dolore e nelle offese patite, nelle responsabilità che avevamo dovuto assumerci. In altre parole guardavamo le cose con altro giudizio e avevamo nei loro confronti un altro comportamento. Così, alle angosce giovanili, alle vaghe inquietudini e alle sfibranti ossessioni, avevamo sostituito, o andavamo sostituendo, una coscienza più ferma e una consapevolezza cresciuta in prove di vita, non solo secondo umori e insoddisfazioni.
Eppure, nonostante tale processo di mutamento, ciò che continuava in modo tenace a resistere nel mondo espressivo di Migneco era il legame con la sua isola, con la gente della sua terra, che ora però pareva scoprire in una misura meno soggettiva, più collegata cioè alle circostanze oggettive dell'esistenza. Anche il colore aveva perso la macerazione tipica degli anni di «Corrente»: il rosso appariva più vivido, più acceso, il verde s'era fatto brillante, l'azzurro aveva inaugurato la propria presenza. Pescatori, venditori di pesci, cacciatori, donne al lavoro, contadini: ogni personaggio stava acquistando così una fisionomia di più sicura consistenza e verità.
Almeno sino alle soglie del '48, Migneco ha insistito in questa ricerca, quale complessa preparazione alla scelta successiva, che lo impegnerà per dieci anni con risoluta convinzione. Sono gli anni del realismo. Il fascino di Picasso era penetrato negli studi, aveva conquistato gli artisti. Era la conseguenza logica di un lungo amore. Molti di noi avevano attraversato la guerra con la fotografia di Guernica nel portafoglio ed era un amore che avevamo diffuso. Anche Migneco ne avvertì la suggestione, ma non certo ne fece una maniera come accadde invece a parecchi altri. Egli cioè fu ben lontano dall'accogliere la lezione cubista come una grammatica per felici impaginazioni, per costruire particolari ritmi compositivi e stendere squillanti piani cromatici. Il suo cubismo è nato solo dall'esigenza di rendere più drastica e contratta l'immagine, per imprimere in essa uno scatto più decisivo d'energia, per guarirla dalle macerazioni esacerbate dell'espressionismo prebellico. Duro e tagliente, egli riuscì così a foggiarsi un linguaggio cuboespressionista originale ed energico, dove non solo confluiva, rinnovata, la lezione delle avanguardie, ma anche il senso più remoto di altre tradizioni primitive o arcaiche, bizantine o romaniche, ch'egli scopriva riconoscendo in sé il fluire riemerso di un'antica e quasi ancestrale vena popolare, un'attiva schiettezza verso le cose elementari e gli uomini che da sempre compiono i gesti del lavoro e della vita come semplici ma solenni gesti rituali. Così fu dunque il suo realismo.
La fatica sulla terra e sul mare, la pena dell'esistenza, la morte e i lutti, la protesta, le lotte: nessuno di questi temi è sfuggito a Migneco in quegli anni, ma tutto ciò nella verità dei personaggi, senza ideologismi astratti. Sono anni, questi dieci anni, in cui Migneco, nella luce accecante di una memoria che ritrova ogni dettaglio, ogni significato riposto, dipinge l'epos di una Sicilia memorabile, dei suoi protagonisti carichi di una civiltà assorbita in millenni di storia, delle sue contraddizioni storiche: le madri solitarie davanti alle acque dello Stretto, la liturgia delle stagioni e dei campi, l'antico mestiere di campare la vita con le barche e le reti, le maledizioni secolari, le oppressioni, le rivolte. In alcune di queste sue opere, il segno è così inciso e crudele, così tranciante, che il sentimento più segreto della sua ispirazione ne prorompe di colpo, senza incertezze. Si sprigionano allora, da queste opere, amore e furore, dolore e rabbia insieme. Quante di queste opere sarebbero da citare. Il colore stesso si fa più folto di risonanze, si carica di viola, di verdi smeraldo, di gialli sulfurei, di bianchi balenanti. È lo stesso lamento quasimodiano per il Sud che si alza da queste tele: «Oh, il Sud è stanco di trascinare morti... è stanco di solitudine...».
Di questo Migneco diede ampia informazione la Biennale veneziana del '58 con sedici opere, tra cui la Famiglia dei pescatori, Contadini nell'aranceto, Le sementi, opere indubbiamente salienti lungo il suo itinerario creativo, ma anche opere che in qualche modo concludevano il ciclo di questi dieci anni centrali della sua attività. Si sa che è proprio in questo periodo che il realismo come movimento entra in crisi. Le ragioni sono molte e non è qui il luogo per prenderle in esame. Dirò soltanto che, nell'area del socialismo, molte certezze, per tutta una serie di drammatici avvenimenti, si aprivano al dubbio, a nuove inquietudini e angosce. Era naturale quindi che anche gli artisti ne risentissero. Ma ciò accadde in maniera diversa per molti di loro. Per chi aveva aderito alle ragioni del realismo soltanto come a una delle tante mode che poi si sarebbero avvicendate rapidamente in seguito, non ci furono né crisi né problemi: si sciolse dall'impegno con decisione indolore e raggiunse incolume altri spazi operativi. Per chi invece era stata la logica conseguenza di una lunga e meditata ricerca, le cose andarono in altro modo. Cioè, non si trattò affatto di rinunciare, ma di continuare a cercare, di rendersi conto, di capire insomma, e quindi assumere nuove responsabilità verso se stessi e il proprio lavoro. Fu così per molti, diciamo per tutti i migliori, che nel movimento avevano dato le opere più importanti. Accadde così anche per Migneco.
È a cominciare dal '60 che le sue tele danno segno di una direzione tematica e formale nuova. Ma, in realtà, nuova sino a che punto? Certamente appare diversa la maniera del dipingere: se cioè, negli anni precedenti il suo cuboespressionismo preferiva il segno curvilineo inciso e tagliente, ora si mostra più incline a una linea verticale, che tende a sfaldarsi, a perdere secchezza. Così il colore, che sfuma, s'intorbida, perde in nitidezza, infoltendosi volentieri anche in macchie approssi-mative. Quanto al resto, Migneco, tende a sviluppare una vena che già possedeva, anche se rimasta in ombra per la preponderanza di altri impulsi più forti. Parlo della vena satirica. Nel temperamento di Migneco infatti è senz'altro presente anche una vivace natura di moralista, di critico del costume. Ora, è appunto in tale direzione. che, sino al '64, egli inventa preferibilmente personaggi borghesi e piccoloborghesi occupati nelle loro imprese «sociali»: lo Strip-tease patriottico, il Viaggio di nozze, la Signora in poltrona, sono alcuni dei suoi quadri di questo tipo. Non è beninteso una tematica assoluta, ma certo è la più ripetuta. C'è da chiedersi tuttavia se, in simile situazione, Migneco potesse sentirsi appagato pienamente, se cioè la sua natura creativa e ideale non ne sentisse limiti o freni.
Sembrerebbe di sì se già, tra un quadro e l'altro di questo genere, egli non poteva fare a meno d'introdurre, benché con minore rilievo e senza mutare di modi, immagini richiamanti soggetti passati.
Ma nemmeno questo lo confortava. Di originale, in tale protratto intermezzo, aveva però scoperto il tema urbano. Perché dunque non portarlo più a fondo, ricavandone ogni possibile esito, trattandolo con la maggiore intensità, dandogli uno spessore più rimarchevole e forte? È appunto quello che Migneco ha fatto in questi ultimi quattro o cinque anni. La sua natura d'artista non ne ha sofferto, anzi si è rinsaldata, ha ripreso nuova energia, nuova spinta. Sembra cioè che Migneco abbia ritrovato se stesso compiutamente, senza dimenticare in alcun modo le sue radici, i dati fondamentali del suo mondo poetico, della sua origine isolana. Egli così ha dipinto e dipinge la città come un deserto, come un luogo disumano e crudele, estraneo e nemico. Può sembrare che il ricordo mitico e favoloso della Sicilia sia scomparso dal suo orizzonte, ma così non è. Nella condanna all'esilio dentro la città oppressiva è infatti implicito il distacco dall'umana condizione della propria terra. E infatti l'uomo sottratto alla propria identità, gettato in un am-biente altro, ch'egli oggi rappresenta.
Sbaglierebbe quindi chi volesse interpretare questo ultimo Migneco in chiave metafisica. Le immagini ch'egli dipinge presentano situazioni indecifrabili perché la realtà stessa contiene concreti motivi indecifrabili di alienante ostilità. Le sue immagini cioè non rimandano a nulla fuori dei nostri confini, fuori dalla nostra vicenda d'ogni giorno. Uomini soli, uomini che non s'intendono, che stanno in chiuse stanze o dentro le quinte astratte delle strade come dentro le scene di un teatro enigmatico quali attori di un dramma senza trama, senza inizio né fine. La rappresentazione si è fatta più sintetica, la composizione procede per piani più netti, i personaggi appaiono più scanditi. Ma tutte le risorse della pittura prece-dente, dall'epoca di «Corrente» in avanti, riconfluiscono nelle tele odierne e vi riconfluisce il colore in ogni sua qualità dissonante e violenta. Che dire di questo ultimo Migneco? La componente espressionista è ritornata a mostrarsi prepotente, ma al tempo stesso la componente realistica, così come l'esigenza cubista di definire i margini e gli spazi dell'immagine. In più, all'interno di questa nuova disposizione di Migneco, è scattato il meccanismo che sa tradurre le nuove inquietudini, le nuove e più coscienti angosce, in termini di maggiore invenzione e fantasia figurativa.
Si può parlare di espressionismo realistico? Si può pensare addirittura che Migneco sia oggi arrivato a un realismo visionario? La voglia di formulare qualche definizione del genere, lo confesso, è senz'altro una tentazione invitante: i critici, si sa, sono deboli di fronte a simili tentazioni. Ma qui vorrei lasciar stare e invitare al rapporto coi quadri senza preoccupazioni che non siano quelle di riceverne emo-zioni, stimoli e pensieri.
Quello che posso dire, a tanta distanza di anni, è che Migneco non è cambiato, è rimasto lo stesso uomo di «Corrente», anche se gli anni, uno dopo l'altro, su di lui, su di noi, hanno caricato un peso non trascurabile. È sempre lo stesso personaggio, mite, schivo e taciturno, e tuttavia umanissimo e fedele. Tutto ciò che lo distrae dalla sua pittura lo mette a disagio Ogni tanto lo incontro ancora in via Brera, alla Galleria Trentadue; qualche rarissima volta lo vado a trovare; oppure lo sento per telefono. Neppure i discorsi paiono mutati. Ma è una falsa impressione. In realtà, come sempre, senza declamazioni o retorica, eg,li continua ad essere attento e presente, sensibile a quanto gli accade intorno, eccitato a interpretarlo. Ecco dunque il perché anche i suoi ultimi quadri ci comunicano una tensione spirituale che non è caduta di tono. Davanti alle sue tele, infatti, Migneco sembra avere conservato l'acutezza e il fervore di un tempo. Al di là di ogni speranza delusa, a dispetto di ogni prova contraria, è proprio questa ostinata e testarda fiducia nell'uomo che continua a reggere il suo lavoro, ed è proprio questa ostinazione, che attingendo alla sua amarezza remota, infonde ancora nella sua opera quel-l'impuntatura morale che la distingue. Questo è dunque il pittore che amiamo. È inutile, oggi come un tempo, domandargli morbidezze e astuzie. Aspro e umano, amaro e solidale, ecco Migneco. Ecco da quale «sostanza» scaturisce l'autenticità delle sue immagini, ieri come oggi.
|