Semifreddi
|
|
|
Come
un gioco Mi svegliai di soprassalto
che passava bassa una formazione. Poi ne passarono altre altissime,
poi altre ancora con un rombo diverso. Pareva che andassero in tutte
le rotte e a tutte le altezze. Il cielo si era scoperchiato arrovesciandosi
con tutte le stelle dietro le colline, lasciando un gran vuoto tenebroso
nel quale gli aeroplani si cacciavano in fretta. Non sapevo se altri
erano svegli, ma da un capo all’altro del dormitorio non si
sentiva nè un fruscio nè un bisbiglio; tutti immobili,
morti e già numerati in un bollettino ufficiale. Eccoci qua
tutti in fila; mia moglie, mia cugina l’ospite, questa torinese
dagli occhi tondi di malaugurio, mia cognata, le tre ragazze con
imprigionata in mezzo la fidanzata del fratello, la madre del fidanzato,
il fidanzato, e poi un limbo di sconosciuti, giù fino al
muro della casupola. È questo un gioco; stiamo tutti qui,
l’uno accanto all’altro, giocando a nasconderci e ad
aver paura. Gioca anche questo pilota che si ostina a girare sulla
vallata col suo balocco di gran lusso. Egli si trastulla con le
leve, con le manette, con i quadranti, o non è mai pago di
allietarsi alla docilità dei suoi strumenti. Tutto è
lucido e preciso: le luci variopinte sono dolcemente smorzate, i
metalli luccicano ciascuno al suo posto. I numeri sui quadranti
hanno un’ingenuità elementare e una fedele letizia.
Le mani si muovono come da se stesse. Non un’esitazione, non
un impaccio, ogni gesto trova a ogni istante il suo giusto incavo
nell’aria. Non c’è altra legge all’infuori
del gioco perfetto degli strumenti. Che cosa fa laggiù tutta
quella gente addormentata? La legge è ch’essi passino
senza accorgersi dal sonno alla morte se è vero che questo
pedale risponde agevolmente al suo scopo. Un gioco è la morte
come un gioco è la vita. Essi si sono trastullati a costruire
le loro case, pietra su pietra, a una a una battute col martello
e spalmate di calce. Con legno, ferro e tessuti hanno messo su i
loro letti. Hanno imbandito una mensa, hanno inventato ripostigli
da chiudere a chiave, congegni da fermar bene porte e finestre.
Hanno appeso quadri alle pareti, disposto ninnoli sui mobili. Sopra
un tavolino c’è un libro aperto. Sui davanzali ci sono
vasi fioriti. Qui gli uomini passano il tempo a tenersi in vita.
Fanno i figli e li mandano a scuola. Abbracciano le loro donne,
piangono i loro morti. Gioco per gioco noi ci siamo trastullati
a scavare la terra, ad abbattere le foreste, a forzare i fiumi,
a riempire di rombi gli oceani e i continenti.
Michele Mancuso, La gente se ne va
|
|
Siamo
ladri di Gandhi
Voglio dirvi che, in certo modo, siamo ladri. Se
prendo una cosa della quale non ho bisogno per mio uso immediato
e la tengo, la rubo a qualcun altro. Oso dire che è legge
fondamentale della natura, senza eccezioni, che la natura di giorno
in giorno produce quel tanto che basta alle nostre necessità,
e se soltanto ciascuno prendesse quello che gli è sufficiente
e nulla di più, in questo mondo non ci sarebbe miseria, in
questo mondo non ci sarebbe gente che muore di fame. Ma fino a quando
accettiamo l’ineguaglianza, rubiamo. Non sono socialista e
non voglio espropriare coloro che posseggono, ma dico che, personalmente,
quelli tra noi che vogliono vedere la luce oltre le tenebre devono
seguire questa regola. Non voglio spossessare nessuno. […]
Se qualcun altro possiede più di me, sia pure. Ma in tanto
in quanto la mia vita dev’essere regolata, dico che non oso
possedere nulla di cui non abbia bisogno.
[…] Non-possedere è legato a non-rubare. Una cosa che
originariamente non sia stata rubata, deve tuttavia considerarsi
proprietà rubata, se la si possiede senza averne bisogno.
[…] La nostra ignoranza o indifferenza riguardo alla legge
divina, che di giorno in giorno dà all’uomo il suo
pane quotidiano e nulla più, ha dato origine alle ineguaglianze
e a tutte le relative miserie. I ricchi hanno una quantità
superflua di cose di cui non hanno bisogno, e che perciò
sono trascurate e sciupate, mentre milioni di individui muoiono
di fame per mancanza di sostentamento.
Se ciascuno possedesse soltanto quello che gli occorre, nessuno
sarebbe nel bisogno e tutti vivrebbero soddisfatti. Così
come stanno le cose, i ricchi sono insoddisfatti non meno dei poveri.
Il povero vorrebbe diventare milionario, e il milionario multimilionario.
I ricchi dovrebbero prendere l’iniziativa di privarsi dei
loro possessi allo scopo di diffondere universalmente lo spirito
di appagamento. Se soltanto mantenessero le loro proprietà
entro limiti moderati, l’affamato sarebbe facilmente nutrito
e imparerebbe insieme al ricco la lezione dell’appagamento.
[…] L’eguaglianza economica è la chiave di volta
dell’indipendenza non-violenta. Lavorare per l’eguaglianza
economica vuol dire abolire l’eterno conflitto tra capitale
e lavoro. Vuol dire da un lato abbassare i pochi ricchi nelle cui
mani si concentra la maggior parte della ricchezza della nazione,
e dall’altro innalzare i milioni di individui nudi e semiaffamati.
Un sistema di governo non-violento è evidentemente impossibile
fino a quando persiste il profondo abisso tra i ricchi e le moltitudini
di affamati. […] Una rivoluzione violenta e sanguinosa è
inevitabile, un giorno o l’altro, a meno che non si giunga
a una volontaria rinuncia delle ricchezze e del potere che le ricchezze
danno, e a una loro suddivisione per il bene comune. […] È
vero che è difficile da attuare. Anche la non-violenza è
difficile da conquistare.
|
|
Povertà
volontaria di Gandhi
Quando mi trovai trascinato nel tumulto della politica,
mi chiesi cosa occorresse per rimanere intatto dall’immoralità,
dalla menzogna, da quello che si usa chiamare profitto politico.
Giunsi alla precisa conclusione che, se dovevo servire il popolo
in mezzo al quale ero stato gettato a vivere e delle cui difficoltà
ero testimone giorno dopo giorno, dovevo rinunciare a ogni ricchezza,
a ogni possesso.
A dire il vero, non posso dirvi che, quando giunsi a questa persuasione,
rinunciai immediatamente a ogni cosa. Devo confessare che il progresso
dapprima fu lento. E ora, rammentando quei giorni di lotta, ricordo
che all’inizio fu anche doloroso. Ma, col passare dei giorni,
vidi che dovevo gettare a mare molte altre cose che solevo considerare
mie, e giunse il momento in cui diventò motivo di gioia positiva
rinunciare a quelle cose. Allora l’una dopo l’altra,
con progressione quasi geometrica, le cose scivolarono via da me.
E, dato che sto descrivendo le mie esperienze, posso dire che un
gran peso mi cadde dalle spalle e sentii che ormai potevo camminare
agevolmente e compiere la mia opera al servizio dei miei simili
con grande consolazione e gioia ancora maggiore. Il possesso di
qualunque cosa diventò allora un fastidio e un peso.
Riflettendo sul motivo di quella gioia, scoprii che, se consideravo
mia una cosa, dovevo difenderla contro il mondo intiero. Scoprii
che molta gente non aveva quella cosa, pur avendone bisogno; e che
avrei dovuto perfino ricorrere all’assistenza della polizia
se qualche persona affamata, colpita dalla carestia, trovandomi
in un luogo solitario, avesse voluto non solo dividere quella cosa
con me, ma spossessarmene.
E mi dissi: se la desiderano e volessero prendersela, non lo farebbero
per alcun motivo malvagio, ma lo farebbero perché il loro
bisogno è maggiore del mio. E mi dissi: il possesso mi sembra
un crimine; posso possedere certe cose soltanto se so che altri,
che pure le desiderano, sono in grado di averle. Ma sappiamo - ciascuno
di noi può parlare per esperienza - che questo è impossibile.
Perciò, l’unica cosa che può essere posseduta
da tutti è il non-possesso, non avere assolutamente nulla.
O, in altre parole, una cessione volontaria [...] Perciò,
avendo in me questa convinzione assoluta, dev’essere mio costante
desiderio che anche il mio corpo si abbandoni alla volontà
di Dio, e, finché è a mia disposizione, venga usato
non per la dissipazione, l’intemperanza, il piacere, ma soltanto
per servire e servire durante tutte le ore di veglia. E se questo
è vero riguardo al corpo, quanto più riguardo agli
abiti e alle cose che usiamo?
E coloro che hanno messo in pratica questo voto di povertà
volontaria nella maggior misura possibile - raggiungere la perfezione
assoluta è impossibile, ma la maggiore possibile a un essere
umano - coloro che hanno raggiunto l’ideale di questo stato,
testimoniano che quando ci si spoglia di tutto quello che si possiede,
si possiedono veramente tutti i tesori del mondo.
|
|
Chi
controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente
controlla il passato
[…] la cosa terribile era che poteva essere
tutto vero. Se il Partito poteva ficcare le mani nel passato e dire
di questo o quell’avvenimerito che non era mai accaduto, ciò
non era forse ancora più terribile della tortura o della
morte?
[…] E se tutti quanti accettavano la menzogna imposta dal
Partito, se tutti i documenti raccontavano la stessa favola, ecco
che la menzogna diventava un fatto storico, quindi vera. "Chi
controlla il passato" diceva lo slogan del Partito "controlla
il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato."
E però il passato, sebbene fosse per sua stessa natura modificabile,
non era mai stato modificalo. Quel che era vero adesso, lo era da
sempre e per sempre. Era semplicissimo, bastava conseguire una serie
infinita di vittorie sulla propria memoria. Lo chiamavano "controllo
della realta".
[…]Il giornale di oggi riportava i dati della produzione effettiva,
dai quali traspariva che le previsioni erano grossolanamente errate,
in ogni dettaglio. Il compito di Winston consisteva nel rettificare
i dati originari, facendoli coincidere con quelli odierni.
[…]Pochissimo tempo prima, a febbraio, il Ministero dell’Abbondanza
aveva promesso (le fonti ufficiali avevano parlato di "categorico
impegno") che nel corso del 1984 non ci sarebbe stata alcuna
riduzione nel razionamento del cioccolato. In realtà, come
Winston sapeva bene, per la fine della settimana la razione di cioccolato
sarebbe stata ridotta da trenta a venti grammi: bastava sostituire
alla promessa originaria l’avvertenza che forse per il mese
di aprile si sarebbe dovuti ricorrere a una riduzione della razione
di cioccolato.
[…] Giorno dopo giorno, anzi quasi minuto dopo minuto, il
passato veniva aggiornato. In tal modo si poteva dimostrare, prove
documentarie alla mano, che ogni previsione fatta dal Partito era
stata giusta; nello stesso tempo, non si permetteva che restasse
traccia di notizie o opinioni in contrasto con le esigenze del momento.
La storia era un palinsesto che poteva essere raschiato e riscritto
tutte le volte che si voleva. In nessun caso era possibile, una
volta portata a termine l’opera, dimostrare che una qualsiasi
falsificazione avesse avuto luogo. La sezione più ampia dell’Archivio,
[…] era formata da persone il cui unico compito consisteva
nel reperire e acquisire tutte le copie di quei libri, giornali
o altri documenti che, essendo state sostituite, era necessario
distruggere un numero del «Times» che era stato forse
riscritto una dozzina di volte a seguito di cambiamenti nella linea
politica o in conseguenza di profezie errate del Grande Fratello
era ancora lì, in archivio, con la sua data originaria, e
non esisteva nessun’altra copia che potesse contraddirlo.
[…]
In realtà, pensò Winston mentre rimetteva a posto
le cifre fornite dal Ministero dell’Abbondanza, non si trattava
neanche di falsificazione, ma solo della sostituzione di un’assurdità
con un’altra. […] Le statistiche, tanto nella loro versione
originaria che in quella rettificata, erano un puro e semplice parto
della fantasia. In molti casi ve le dovevate cavare dal cervello
da soli. Le proiezioni fatte dal Ministero dell’Abbondanza,
per esempio, avevano fissato a 145 milioni di paia la produzione
di scarpe per il trimestre in corso. Era poi pervenuta la notifica
che la produzione effettiva era stata di 62 milioni. Winston, tuttavia,
nel riscrivere la proiezione, aveva ridimensionato la cifra portandola
a 57 milioni, in modo che si potesse dire, come al solito, che si
era andati oltre la cifra stabilita. In ogni caso, 62 milioni era
una cifra che non si accostava alla verità più di
57 o 145 milioni. Con ogni probabilità, non era stato prodotto
neanche un paio di scarpe. Con probabilità anche maggiore,
nessuno sapeva, nè gli importava granché saperlo,
quante paia di scarpe fossero state prodotte. Quello che tutti sapevano
era che ogni trimestre veniva prodotto sulla carta un quantitativo
astronomico di scarpe, mentre una buona metà della popolazione
[…] andava a piedi nudi.
da George Orwell, 1984, Mondadori
|
|
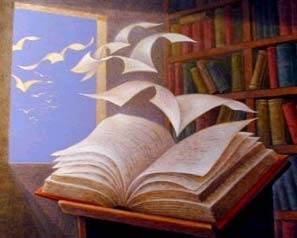

|
Il
maestro
[…] Di libri di testo, di cui sentiamo tanto
parlare, non provai mai il bisogno. Non ricordo neppure di aver
fatto molto uso dei libri di cui potevamo disporre. Non trovo affatto
necessario caricare i ragazzi di grandi quantità di libri.
Ho sempre pensato che il vero libro di testo dell’allievo
è il maestro. Rammento ben poco di quello che i miei maestri
mi hanno insegnato dai libri, ma ancora oggi ho un chiaro ricordo
delle cose che mi hanno insegnato indipendentemente dai libri.
I fanciulli apprendono molto di più e con molta minor fatica
con le orecchie che con gli occhi. Non ricordo di aver mai letto
un libro dalla prima all’ultima riga con i miei ragazzi. Ma
diedi loro, con le mie parole, tutto quello che avevo assimilato
dalla lettura di vari libri e oso dire che ne conservano ancora
il ricordo nella mente. Era faticoso per loro rammentare quello
che imparavano dai libri, ma quello che dicevo loro a viva voce
sapevano ripeterlo con la massima facilità. Leggere era per
loro un dovere, ma ascoltarmi era una gioia – quando non li
annoiavo, non riuscendo a rendere interessante il mio argomento.
E le domande che le mie parole suggerivano loro mi davano una misura
della loro capacità di comprensione.
[…] Come l’educazione fisica doveva essere impartita
mediante l’esercizio fisico, cosi l’educazione dello
spirito era possibile soltanto mediante l’esercizio dello
spirito. E l’esercizio dello spirito si fondava interamente
sulla vita e sul carattere del maestro. Il maestro doveva fare molta
attenzione a quello che diceva o faceva, sia che fosse o non fosse
tra i suoi ragazzi.
[…] Sarebbe inutile, se fossi bugiardo, insegnare ai ragazzi
a dire la verità. Un maestro vile non riuscirà mai
a rendere i suoi ragazzi coraggiosi, e uno lontano dall’auto-disciplina
non potrà mai insegnarne il valore ai suoi discepoli. Vidi
perciò che dovevo essere una continua lezione per i ragazzi
e le ragazze che abitavano con me. In tal modo essi diventarono
miei maestri, e imparai che dovevo essere buono e vivere rettamente
se non altro per amor loro. Posso dire che la disciplina e le restrizioni
maggiori che m’imposi alla fattoria Tolstòj furono
in grandissima parte dovute ai miei pupilli.
Uno di loro era indisciplinato, turbolento, incline a mentire e
litigioso. Un giorno esplose con estrema violenza. Ero esasperato.
Non punivo mai i miei ragazzi, ma questa volta ero molto arrabbiato.
Cercai di ragionare con lui. Ma era impenitente e cercò perfino
d’ingannarmi. Alla fine presi una riga che avevo a portata
di mano e lo colpii sul braccio. Tremavo quando lo percossi. Credo
che se ne accorgesse. Fu un’esperienza assolutamente insolita
per tutti loro. Il ragazzo scoppiò a piangere e chiese perdono.
Piangeva non perché la percossa era stata dolorosa; se cosi
fosse stato, avrebbe potuto rendermi pan per focaccia, essendo un
ragazzo solidamente costruito di diciassette anni; ma si rese conto
della mia pena per esser stato costretto a questo mezzo violento.
Dopo l’incidente non mi disubbidì mai più. Ma
mi pento ancora di quella violenza. Temo che quel giorno gli mostrai
non lo spirito, ma il bruto che era in me.
Sono sempre stato contrario alle punizioni corporali. Ricordo soltanto
un’occasione in cui punii fisicamente uno dei miei figli.
Perciò non sono ancora riuscito a stabilire se ho avuto torto
o ragione a usare il regolo. Probabilmente fu un errore, perché
fui spinto dall’ira e dal desiderio di punire.
Fosse stata soltanto un’espressione della mia angoscia, l’avrei
ritenuta giustificata. Ma in questo caso il motivo era confuso.
[…] In seguito vi furono spesso casi di cattiva condotta da
parte dei ragazzi, ma non ricorsi mai alla punizione corporale.
Così, sforzandomi di impartire un’educazione spirituale
ai ragazzi e alle ragazze che avevo sotto di me, giunsi a comprendere
sempre meglio la forza dello spirito.
Gandhi
|
|


|
Il
fiume Pof
Io ho un cane.
Non ce l’ho da molto. È un bel cane biondo pelocorto.
Tipo labrador, ma piu magro. È un piccolo e magro finto-labrador.
L’ho chiamato Perry Bau. […] a volte me lo ritrovo faccia
a faccia in salotto, mentre magari sono lì buttata su una
poltrona che penso. Io penso e lui mi guarda. È capace di
guardarmi fisso per ore. Quindi diciamo che mi capita spesso, in
salotto, di pensare insieme a lui. È come se ci parlassimo,
tra di noi. Tutti e due zitti.
Ad esempio adesso sto cercando di spiegargti che cos’è
il Pof. Lui crede che sia un pupazzetto di gomma che fa gnau-gnau
tra i denti.
« No » gli dico, « è dove finiscono i Progetti.
»
« Allora » mi fa, « è un fiume? »
La capacità canina di comprendere le cose al di là
delle parole mi sorprende sempre di più. Ma sì, diciamo
che il Pof è un fiume. Nel fiume Pof si gettano tutti i progetti,
come tanti affluenti: affluiscono lì! Il Pof è un
contenitore fluido di tutti i progetti: dunque, un fiume. […]
E, siccome i progetti sono quel che caratterizza una scuola, il
Pof, in quanto raccoglitore di progetti, è una specie di
carta d’identità della scuola.
[…] Quindi il Pof fornisce l’identità di una
scuola in base ai progetti che quella scuola offre. Non per nulla
Pof vuol dire Piano dell’Offerta Formativa.
Intanto, è un piano. Hai presente? Come i piani bellici,
o i piani regolatori. E tin progetto anche lui, insomma, ma un progetto
gigante che li contiene tutti, in modo che tutti insieme permettano
di « pianificare l’offerta ».
Lo so che la parola offerta ti fa venire in mente quando andiamo
al supermercato e le scatolette del tuo cibo sono in offerta, lo
so. Ma non devi fare queste associazioni libere, sono pericolose.
Dunque, il Piano dell’Offerta Formativa è la pianificazione
di ciò che una determinata scuola ti offre per formarti.
Come alle terme. Sei mai stato alle terme? Se tu vai alle terme,
ti danno un depliant in cui ti spiegano nel dettaglio cosa ti offrono:
bagno turco, massaggi ayurvedici, fanghi, saune, docce fredde...
Il gioco sta nel distinguersi. Le terme non sono tutte uguali. Ci
sono terme e terme. Per questo ti faccio il dèpliant, perchè
tu, utente-paziente-cliente-studente o cane, possa scegliere le
terme migliori.
Cosa sta succedendo? Semplice: di colpo la scuola, che evidentemente
non è una stazione termale, si mette a fare un’offerta.
Ogni scuola pubblicizza le sue offerte, che la differenziano dalle
altre scuole. Di colpo, dunque, le scuole non sono più tutte
uguali: una scuola offre una cosa e un’altra scuola ne offre
un’altra. Chiaro.
Strano... Mi sfugge qualcosa. Per esempio, non riesco a capire che
cosa possa mai offrire di sconvolgentemente nuovo un insegnante
di italiano, cosa può mai inventarsi, se non di insegnare
bene la sua materia e cioè insegnare a leggere dei bei libri
e capirne il senso nel profondo; esprimere per iscritto il proprio
pensiero, o un racconto, un ricordo, un ritratto; saper tenere un
discorso avvincente, ben costruito, persuasivo. Che altro? Che cosa
potrà mai offrire di diverso l’insegnante di italiano
della scuola vicina e concorrente? Perchè di colpo abbiamo
dei concorrenti?
Risposta facile: c’è l’autonomia. Ogni scuola,
nell’era dell’autonomia, è libera di scegliere
che cosa offrirti, cioè quali progetti presentarti. Per esempio,
un bel Corso di Chitarra o di Giardinaggio.
Come sarebbe, cosa c’entra? C’entra eccome. Se per esempio
un insegnante d’italiano ritiene che, per farti sentire meglio
il ritmo di una pagina di Calvino, sia necessario che tu impari
a suonare la chitarra, presenterà il Progetto Chitarra al
collegio docenti e, dctto fatto, di colpo il suo progetto lo distinguerà
da tutti gli altri insegnanti di italiano, rimasti drammaticamente
fermi a insegnare la loro antiquata e decrepita materia, fatta solo
di grammatica, vita e opere, commenti e riassunti.
I Progetti distinguono una scuola.
Come dici? Tu avresti detto gli insegnanti? Altra stupidaggine.
Si vede che sei un cane. Gli insegnanti non contano niente. E nemmeno
le cose che insegnano, o i modi che usano per insegnarle. Contano
solo le cose extra, le cose « fuori »: i progetti, appunto.
I curatori del progetto, non gli insegnanti. Le attività,
non le materie.
Nel Pof troverai che in una scuola si fa il Corso di Cucito o l’Approfondimento
Zen o la Preparazione per il First, per il Delf o l’Uscita
al Museo del Cinema e la Gita di Istruzione sulle Rocce Dolomitiche.
Non troverai chi insegna e che cosa e come. Se cioè un insegnante
di lettere fa letteratura o no, quello non ce lo trovi. E nemmeno
il fatto che il tal insegnante di matematica ha inventato una nuova
formula e lo hanno già indicato per il Nobel. Queste cose
no, queste cose non interessano a nessuno. Non fanno l’identità
di una scuola.
Anche perchè il suddetto insegnante di matematica, per inventare
la sua formula, se ne sta tutti i pomeriggi rintanato in casa a
studiare: non porta mai gli allievi in gita, non offre mai un’attivita
extra sulle Strategie dell’Apprendimento, non fa mai un Corso
di Recupero, nè un’Uscita Didattica al Museo dei Numeri,
niente! È davvero un pessimo insegnante.
Perry Bau mi guarda inquieto. Sente la mia inquietudine.
L’ho chiamato Perry Bau perchè a me piacciono molto
gli sceneggiati tivu di tipo poliziesco, in particolare la serie
di Perry Mason. Quindi il mio cane mi piaceva chiamarlo Perry, come
il mio eroe.
Ma siccome è un cane, gli ho aggiunto il cognome Bau.
(da La scuola raccontata al mio cane di
Paola Mastrocola, Guanda)
|
|


|
Tacere
era bello. Ora non più
Da
qualche anno compiliamo il Documento di Classe. Fa parte dei nostri
« adempimenti d’inizio anno ». Non so se lo prevedono
tutte le scuole, ma credo di sì; forse però nelle
altre scuole potrebbe anche chiamarsi in qualche altro modo. Da
noi si chiama Documento di Classe, ed è una specie di figlio
del Pof: un piccolo Pof in miniatura, che i docenti di ogni singola
classe compilano insieme tra di loro, ognuno per la sua materia,
e che quindi riguarda quella singola classe.
Nel Documento ogni insegnante deve scrivere innanzi tutto quali
sono i suoi Obiettivi. Sulla parola obiettivo vorrei soffermarmi
un po’. La parola obiettivo appartiene all’area semantica
della guerra. Così come « piano » e «
strategia ». Che strano, in un’era che si affanna a
promuovere la pace... L’obiettivo è, nel nostro immaginario
attuale, l ’« oggetto » da colpire con le bombe,
possibilmente intelligenti, un colpo esatto e via. È anche
una parte della macchina fotografica e del telescopio, lo so; ma
indica sempre il mettere a fuoco un bersaglio.
Ora, l’insegnante deve avere dei fini (ovvero bersagli) ?
Non lo so. Credo di sì, ma credo che sarebbe meglio mantenere
una certa inconsapevolezza di sè. Non credo sia bene entrare
in classe avendo stampigliato sulla fronte: io mi propongo
come fine di salvarti dall’ignoranza, aprirti il cervello,
migliorare la tua vita. Quando mi chiedono di compilare le mie «
finalità educative e didattiche », mi viene male. Un
leggero ma penetrante mal di stomaco, con nausea. Mi verrebbe da
scrivere: non ne ho; e se ne ho, non so di averle. Una cosa così.
È come con i figli: noi sappiamo che finalità abbiamo?
No. Cioè sì, ma sono talmente ovvie che, se ce le
chiedessero, scoppieremmo a ridere. Sarebbero quelle di allevare
bene i figli, affinchè siano buoni, saggi, sereni, simpatici,
belli, sani e intelligenti, o no?
Nella scuola è lo stesso; credo che la finalità di
un insegnante sia quella di insegnare meglio che può. È
cosa molto ovvia. Quali altri fini mai potrebbe avere un insegnante?
E allora perchè ci chiedono di dirli?
È brutto dover dire cose ovvie e tacitamente risapute da
tutti. Dire cose ovvie ci umilia sempre un po’, ci fa sentire
tristi e inutili. È come quando ci chiedono: mi vuoi bene?
Siccome e ovvio che ti voglio bene, perchè me to chiedi?
Perchè te lo devo dire? Se me lo chiedi, mi esce solo un
debole e insulso: sì... Tu non ci hai guadagnato niente,
e io mi sono intristita a doverti dire quel pallido sì.
Il punto grave infatti non è se si debbano o no avere dei
fini, e se si debbano dire i propri fini, ovvero, secondo un linguaggio
più moderno e nuovo, se si debbano «esplicitare».
E qui ho le idee infinitamente piu chiare: no. I fini non si devono
esplicitare mai! A meno che non siamo in un’attivita di guerra:
allora certo che sì, i fini militari si devono esplicitare
eccome, almeno a coloro che li devono attuare. Ma noi, a Scuola,
siamo in una dimensione militare? Nonostante le parole militari
che ci obbligano a usare, direi proprio di no. E quindi i fini non
vanno esplicitati.
Karate Kid è un film meraviglioso. E la storia di
un ragazzino che vuole imparare karate e si rivolge a un vecchio
e saggio maestro giapponese.
Il maestro lo accetta come allievo e gli dice di presentarsi
il tal giorno per la prima lezione. Ma poi, invece di far lezione,
gli ordina di dipingere la palizzata che circonda la sua casa, e
gli mostra per bene il gesto con cui deve muovere il pennello su
e giù lungo il legno. Il ragazzo, un po’ malvolentieri,
esegue. Quando ha finito, spera che il maestro gli darà lezioni
di karate. Ma il maestro gli chiede di dipingere anche il retro
della palizzata, e poi di dare una seconda mano, e infine di ridipingere
anche il pavimento all’interno, e qui gli mostra di nuovo
in quale modo usare il pennello. Così per giorni e giorni.
Il ragazzo è ormai al limite della sopportazione, quando
finalmente il maestro accetta di dargli la prima lezione. Gli mostra
i primi movimenti che dovrà saper compiere con le braccia
e... di colpo, vediamo che il ragazzo li conosce già, perchè
sono quegli stessi gesti che ha dovuto imparare per dipingere la
palizzata e poi il pavimento.
Di colpo capiamo che il maestro gliele aveva già date le
lezioni di karate, senza che l’allievo se ne accorgesse, anzi,
proprio nel momento in cui l’allievo pensava di perdere tempo
e di essere preso in giro.
Questo è insegnare.
C’è un enorme valore del silenzio dentro il verbo «insegnare».
Io insegno e non dico qual è il mio fine né qual è
il mio metodo. Insegno e basta. Così come dipingo e
basta, suono e basta, ti amo e basta. Tacere è bello.
Tacere era bello. Ora non più.
Secondo l’attuale nostra scuola, quel maestro giapponese
dovrebbe scrivere nel Pof che intende usare come metodo quello
di far dipingere palizzate per ottenere come obiettivo di insegnare
karate al ragazzo. L’attuale nostra scuola non sembra avere
alcuna idea di che cosa sia un maestro. O meglio, non sembra volere
affatto dei maestri. L’idea stessa di maestro le è
estranea, direi un po’ antipatica.
L’attuale scuola odia i « maestri » . Li trova
snob e antiquati. Poco tecnici, poco flessibili. Dotti e spocchiosi.
Oggettivamente non valutabili. E silenziosi, troppo silenziosi.
Insomma, in brevissimo tempo capii che dovevamo diventare tutti
insegnanti poffati.
Per il nostro nuovo mestiere, erano stati coniati nuovi verbi e
nuovi complementi oggetto. Insegnare e far lezione erano parole
vecchie. Oggi l’insegnante dove fare ben altro. Recupera.
Colma. Accoglie. Progetta. Esplicita.
Pianifica l’offerta, cura l’utenza, individua i percorsi,
stabilisce gli obiettivi, disegna la mappa, costruisce la griglia,
indica i saperi, fornisce un metodo, studia le strategie, usa gli
strumenti, stabilisce i criteri, valuta oggettivamente, si autovaluta,
si monitorizza, certifica le competenze, somministra i test, verifica
in itinere, rispetta gli obiettivi, organizza i moduli, percorre
i percorsi, si aggiorna nei contenuti e nei metodi, mette in atto
il processo educativo, esplicita le competenze, concretizza
le conoscenze, verifica l’apprendimento, si relaziona agli
altri enti - anche e preferibilmente in contesti variabili - governa
i conflitti, lavora sul territorio, innalza il tasso, il successo
scolastico... ma soprattutto è flessibile, flessibile e disponibile,
disponibile al cambiamento...
Un mare.
Un mare di parole nuove mi travolse quando, come dicevo, tornai
a scuola nel 1999. Per questo non riconobbi più nulla e mi
parve che mi avessero cambiato it mondo, spostato l’orizzonte,
trafugato la terra da sotto i piedi. La montagna era andata in pezzi.
E io ero uno dei milioni di sassi rotolati a valle, in tanta lapedicina.
Brancolavo nel vuoto, rasentavo i muri, percorrevo invano corridoi
deserti alla ricerca di qualcuno che mi aiutasse. Che mi dicesse
quali erano i miei obiettivi, i miei metodi, i miei percorsi, le
mie strategie, i miei moduli, le mie competenze...
Di colpo non sapevo pin niente. E non ero niente.
(da La scuola raccontata al mio cane di
Paola Mastrocola, Guanda)
|
|
Mister
Pil
Non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale
soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico, nell’ammassare
senza fine beni terreni.
Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell’indice
Dow-Jones, né i successi del paese sulla base del prodotto
nazionale lordo (PIL).
Il PIL comprende anche l’inquinamento dell’aria e la
pubblicità delle sigarette, e le ambulanze per sgombrare
le nostre autostrade dalle carneficine dei fine-settimana.
Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte
di casa, e le prigioni per coloro che cercano di forzarle. Comprende
programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti
violenti ai nostri bambini. Cresce con la produzione di napalm,
missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare
la disseminazione della peste bubbonica, si accresce con gli equipaggiamenti
che la polizia usa per sedare le rivolte, e non fa che aumentare
quando sulle loro ceneri si ricostruiscono i bassifondi popolari.
Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della
qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti
di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità
dei valori familiari, l’intelligenza del nostro dibattere
o l’onestà dei nostri pubblici dipendenti.
Non tiene conto né della giustizia nei nostri tribunali,
né dell’equità nei rapporti fra di noi. Il Pil
non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio,
né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né
la nostra compassione né la devozione al nostro paese.
Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente
degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull’America,
ma non se possiamo essere orgogliosi di essere Americani.
Discorso di Robert Kennedy, 18 marzo 1968, Università
del Kansas
|
|
 |




