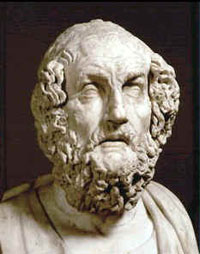|
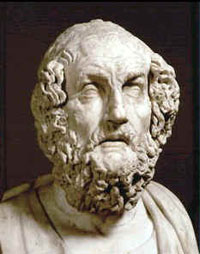

|
La Fornace
Più consistenti e significative sono le due poesie d’ispirazione
popolare, La Fornace e l’Eiresione. Nella
prima il poeta, rivolgendosi ai vasai di Samo, augura ad essi buona
fortuna se gli pagheranno il compenso della sua canzone, altrimenti
minaccia la distruzione della fornace e dei suoi prodotti. E il
tutto dice con tono tra il serio e il faceto, ché nel primo
caso invoca la protezione di Pallade, nel secondo l’intervento
dei demonietti rompitori di vasi, e perfino di Circe, la maliarda,
e dei centauri violenti.
Se voi del canto mio mi darete, o vasai la mercede,
qui vieni, Atena, e su la fornace protendi la mano,
a buon termine fa’ che giungano coppe e bicchieri,
che la cottura giusta ne sia, che li paghino bene
che molti per le vie se ne spaccino, molti al mercato,
ed il guadagno giusto facciate, n’esulti il cuor vostro.
Se poi bando al pudore darete, e sarete bugiardi,
dèmoni qui chiamerò che struggan le vostre fornaci,
Stritola, Spícina, Incénera, insieme con Bòmbito
e Spacca,
che dar sapranno a questa fornace travagli a bizzeffe.
Struggi i fornelli, struggi la casa, e con lei la fornace,
tutto a sconquasso vada, fra un alto fragore di cocci.
Qual di cavallo mugghia la fauce, così la fornace
mugghi, ed a briciole, dentro di sé tutti i vasi riduca.
Figlia del Sole, Circe, maestra di filtri, e tu vieni,
e questi e l’opre loro danneggia coi farmachi tristi.
Anche Chirone venga, qui guidi i Centauri a schiere,
quanti alle mani d’Alcide sfuggirono, e morti non sono,
e pestin tutto quanto, sicché la fornace sprofondi,
sí che dobbiate, piangendo, riflettere ai vostri misfatti.
Io gioirò vedendo distrutte le vostre fatiche.
E se qualcuno farà capolino nel forno, la faccia
tutta gli vada a fuoco; e imparino a fare i bricconi.
Eiresione
Eiresione si chiamava il ramoscello di ulivo o di alloro adorno
di bende, portato dai supplici, ma anche dai ragazzini poveri, che,
in certi giorni dell’anno, andavano chiedendo di casa in casa
piccole offerte in viveri o in danaro; e tale nome aveva pure la
cantilena ch’essi intonavano per l’occasione. Qualcosa
di simile si usa ancora nei paesetti dell’Italia meridionale
il giorno di San Silvestro o di Sant’Antonio. L’Eiresione,
dunque, che, secondo lo Pseudo-Erodoto, Omero avrebbe cantato pure
a Samo, è un canto popolare analogo a quello della rondinella.
E della poesia popolare ha tutta l’ingenua freschezza e grazia
semplice.
Ecco ci siamo rivolti alla casa di un grande signore,
ch’ha gran potere e ha gran voce d’un uomo magnifico
e ricco.
Su, da voi stesse ora apritevi, o porte, poi ch’entra ricchezza,
molta ricchezza, e con essa la gioia fiorente e la buona
pace; e quante anfore dentro vi sono, si colmino tutte;
e dalla madia una bella focaccia giú scivoli sempre,
fatta di fina farina, condita di sesamo e miele.
Ed a voi presto verrà sopra il carro la sposa del figlio,
a questa casa bei muli piè solidi la condurranno,
onde ella tessi la tela, movendo i suoi piedi sull’ambra.
Oh! tornerò, tornerò come torna la rondine ogni anno.
A piedi scalzi qui sto sulla soglia; or via, subito dona,
dona qualcosa, nel nome di Apollo, signor delle vie.
Se dai, o se non dai, non resteremo,
ché non venimmo qui per abitarci.
Batracomiomachia
La Batracomiomachia, ossia la « battaglia delle
rane e dei topi », è un poemetto di 303 esametri, composto
in età ignota, ma certamente piuttosto tarda. Si vuole in
esso parodiare la poesia epica e in particolare l’Iliade,
onde l’assurda attribuzione allo stesso Omero. La parodia
è condotta su un motivo favolistico, la guerra fra animali,
il quale è presente anche nelle raccolte esopiche: donnole
e topi, lupi e cani, aquile e lepri, la biscia e la vipera.
La parodia consiste nel tono generale d’epopea e nel ricalco
di episodi e di espressioni omeriche; e tuttavia riesce per lo piú
insulsa. Una certa freschezza e grazia è data dalla materia
stessa della favola. Anzi, per l’ampliamento del motivo originario,
ch’era tenue, si può parlare piuttosto di fiaba. Si
può vedere in essa un leggero e arguto gioco di fantasia.
Forse per questo il poemetto piacque singolarmente al Leopardi,
che lo tradusse ben tre volte, in sesta rima, secondo la tradizione
metrica dei nostri poemi burleschi e animaleschi, e ne riprese la
trama nel. suo lungo poema satirico in ottave, Paralipomeni della
batracomiomachia.
Origine della guerra
I fatti si svolgono cosí.
Un topo di nome Rubabricciole, sfuggito alle grinfie di un gatto,
capita sulla riva di uno stagno. Un ranocchio del luogo, il principe
Gonfiagote, lo invita a visitare il suo regno. Ma poiché
il topo è inesperto del nuoto, se lo fa montare sulle spalle
e comincia a guizzare a fior d’acqua. Però all’improvviso
apparire di una biscia, egli s’immerge nel fondo, lasciando
nei guai l’ospite, che annaspa disperatamente e sguittisce
di essere tradito: il ranocchio, non potendolo vincere sul solido
terreno, gli avrebbe teso quel tranello. E cosí il topo,
invocando la vendetta divina, muore annegato.
Una volta un topo assetato, che era fuggito al pericolo di un gatto,
accostò l’avido mento al margine di una palude, godendo
dell’acqua dolce. Lo scorse Godipalude, dalla voce grossa,
e cosí gli disse: « Straniero, chi sei? Donde venisti
alle nostre sponde? Chi ti generò? Di’ tutta la verità,
perché non ti sorprenda mendace. Ché se ti ritengo
amico degno, ti condurrò a casa e doni ti darò ospitali,
molti ed eccellenti. Io sono il re Gonfiagote, che nella palude
sono onorato quale capo delle rane per sempre. E mi allevò
il padre Peleo, il Fangoso, che si uni in amore lungo le rive dell’Eridano
con Idromedusa, la Regina delle acque. Anche te vedo e bello e forte,
eccellente sugli altri, re scettrato e in guerra combattente. Ma
tu presto dimmi la tua stirpe ».
E a lui di rimando Rubabricciole: « Perché indaghi
la mia stirpe? È manifesta a tutti e uomini e dèi
e uccelli del cielo. Mi chiamo Rubabricciole: son figlio di padre
magnanimo, Rodipane, e madre mi fu Leccamacine, figlia del re Rodiprosciutti.
Mi generò in un tugurio e mi allevò con cibi, fichi
e noci e vivande di ogni sorta. Come puoi rendere amico me, che
in nulla ti sono simile per natura? Ché tu hai la vita nelle
acque, ed io d’altra parte son solito rodere tutto ciò
che è presso gli uomini: né mi sfugge il pane finissimo
dal rotondo canestro, né la grossa schiacciata con abbondante
sesamo e formaggio, né fetta di prosciutto, né fegati
dalle bianche tuniche, né formaggio or ora rappreso da dolce
latte, né squisita focaccia col miele, ambita anche dagli
dèi beati, né quanti cibi per i conviti dei mortali
fanno i cuochi, adornando le pentole di ogni genere di condimenti.
Non mangio ravanelli né cavoli né zucche, né
mi cibo di bietole verdi, né di prezzemolo: ché questi
sono vostri cibi, di chi abita la palude ».
Sorrise Gonfiagote e di rimando diceva: « Straniero, eccessive
sono le tue vanterie per il ventre: anche noi abbiamo molte meraviglie
nella palude e sulla terra. Ché il Cronide concesse alle
rane duplice pascolo, saltare sulla terra, nascondere il corpo nelle
acque, abitare case distribuite con duplici elementi. Se tu vuoi
esperire anche queste cose, è facile: vienimi sul dorso,
tieniti a me e non scivolare, perché pieno di letizia tu
entri nella mia casa ».
Cosí diceva e offriva il dorso: l’altro prestissimo
vi montava, tenendo le mani sul tenero collo con lieve stretta.
E dapprima godeva quando vedeva le vicine rade, godendo del nuoto
di Gonfiagote. Ma quando era battuto dai flutti ribollenti, molto
lagrimando si rinfacciava l’inutile pentimento, strappava
i capelli, stringeva i piedi contro il ventre, e per mancanza d’abitudine
il cuore gli balzava, e voleva tornare a terra: gemeva dentro di
sé, terribilmente, sotto la necessità del gelido terrore.
E prima adattò la coda alle acque, quasi tirasse un remo,
ma pregando gli dèi di poter tornare a terra era bagnato
dalle acque ondeggianti e invocava aiuto a gran voce. E tali accenti
emise dalla bocca: « Non cosí sul dorso portò
il carico d’amore il toro quando attraverso il flutto portava
Europa a Creta come la rana che stese il topo sul dorso e lo conduceva
a casa sollevando il pallido corpo sull’acqua spumeggiante
».
Una biscia improvvisamente apparve, amara visione per entrambi:
teneva la cervice ritta al di sopra dell’acqua. Gonfiagote
la vide e s’immerse, senza pensare qual amico stesse per abbandonare
alla morte. S’inabissò nella palude profonda ed evitò
il nero destino di morte.
Quello come fu gettato via, cadde supino subito nell’acqua
e serrava le mani e morendo strideva. Ora s’immergeva, ma
di nuovo a forza di calci emergeva dall’acqua: non poteva
sfuggire al destino. I peli bagnati traevano maggior peso su di
lui. Perendo nelle acque, tali detti pronunciava: « Non riuscirai
a lasciare, Gonfiagote, inosservata con l’astuzia la tua impresa,
tu che gettasti il naufrago via dal corpo come da una rupe. Né,
o canaglia, sulla terra mi saresti stato superiore nel pancrazio,
nella lotta e nella corsa; ma con l’inganno mi gettasti nell’acqua.
Dio ha l’occhio vindice ».
Cosí dicendo spirò nelle acque.
Epilogo della battaglia
Gli stridi di Rubabricciole sono
uditi da un altro topo che si trovava per caso sulla riva; è
Leccapiatti, che corre subito a riferire la cosa ai suoi. Il topo
perito nello stagno era il figlio del re Rodipane; cosí tutto
il regno avvampa d’ira. I topi, armati di tutto punto, marciano
contro i ranocchi, che alla notizia prendono anch’essi le
armi, e, schierati sul lido, attendono gl’invasori. Zeus convoca
il concilio degli dei per decidere a chi si debba dare l’appoggio:
ma dietro il saggio consiglio di Pallade tutti sono per la neutralità.
Le zanzare suonano il segnale dell’attacco, e segue la mischia
che si svolge con vari episodi e vicende. I ranocchi hanno la peggio
e stanno per essere distrutti. Ma alle preghiere di uno di essi
Giove si commuove; e per far sospendere la battaglia, scatena una
tempesta di lampi e tuoni. L’espediente, malgrado il momentaneo
scompiglio, riesce poco efficace. Allora il dio, che è deciso
a salvare ad ogni costo i ranocchi, provoca l’intervento dei
granchi; questi, forti delle loro corazze contro cui si spunta ogni
sorta di armi, fanno scempio dei topi e li costringono a ritirarsi.
Giunse a la mischia il prence Rubatocchi,
giovane di gran cor, d’alto legnaggio;
particolar nemico de’ ranocchi;
degno figliuol d’Insidiapane il saggio;
il piú forte dei topi ed il più vago,
che di Marte parea la viva imago.
Questi sul lido in rilevato loco
postosi, a’ topi suoi grida e schiamazza;
aduna i forti, e giura che fra poco
de le ranocchie estinguerà la razza.
E da ver lo farla; ma il padre Giove
a pietà de le misere si move...
Disse; e Giove acconsente, e un dardo afferra:
avventa prima il tuon, ch’assordi e scota
e trabalzi dai cardini la terra;
indi lo strale orribilmente rota;
lo scaglia; e fu quel campo in un momento
pien di confusione e di spavento.
Ma il topo, che non ha legge né freno,
poco da poi torna da capo, e tosto
vanno in rotta i nemici e vengon meno.
Ma Giove, che a salvarli ad ogni costo
deliberato avea, gente alleata
a ristorar mandò la vinta armata.
Venner certi animali orrendi e strani,
di razza sopra ogni altra ossosa e dura:
gli occhi nel petto avean, fibre per mani,
il tergo risplendente per natura,
curve branche, otto piè, doppia la testa,
obliquo il camminar, d’osso la vesta.
Granchi son detti: e quivi a la battaglia
lo scontraffatto stuol non prima è giunto
che si mette fra’ sorci, abbranca, taglia,
rompe, straccia, calpesta. Ecco in un punto
sconfitto è il vincitor; la rana il caccia,
e quelli onde fuggía, fuga e minaccia.
A’ granchi ogni arme si fiaccava in dorso:
fero un guasto, un macello innanzi sera,
mozzando or coda or zampa ad ogni morso.
E già cadeva il Sol, quando la schiera
de’ topi si ritrasse afflitta e muta:
e fu la guerra in un sol dí compiuta.
(trad. Giacomo Leopardi)
|